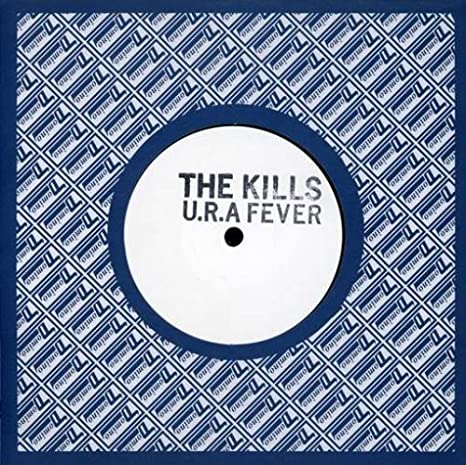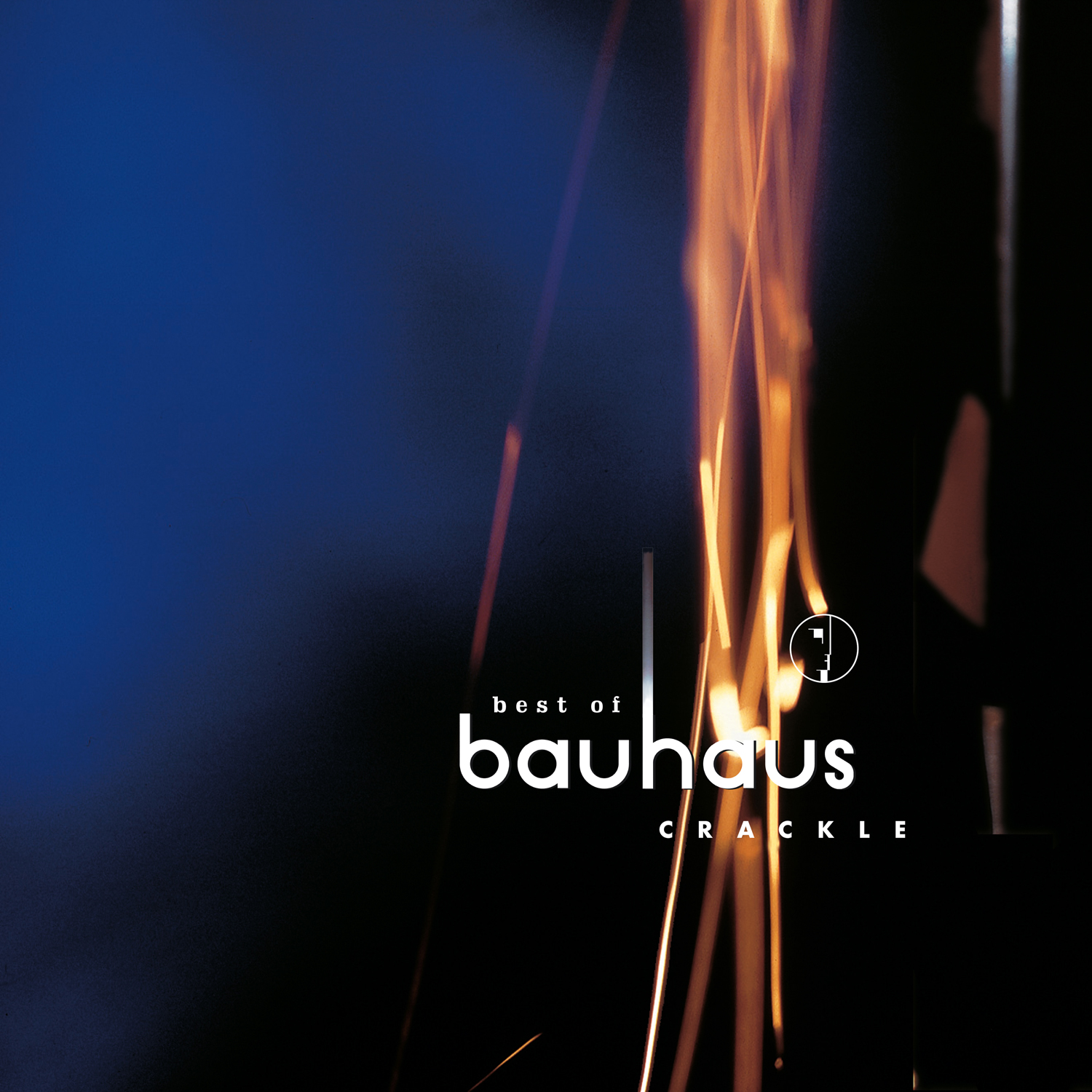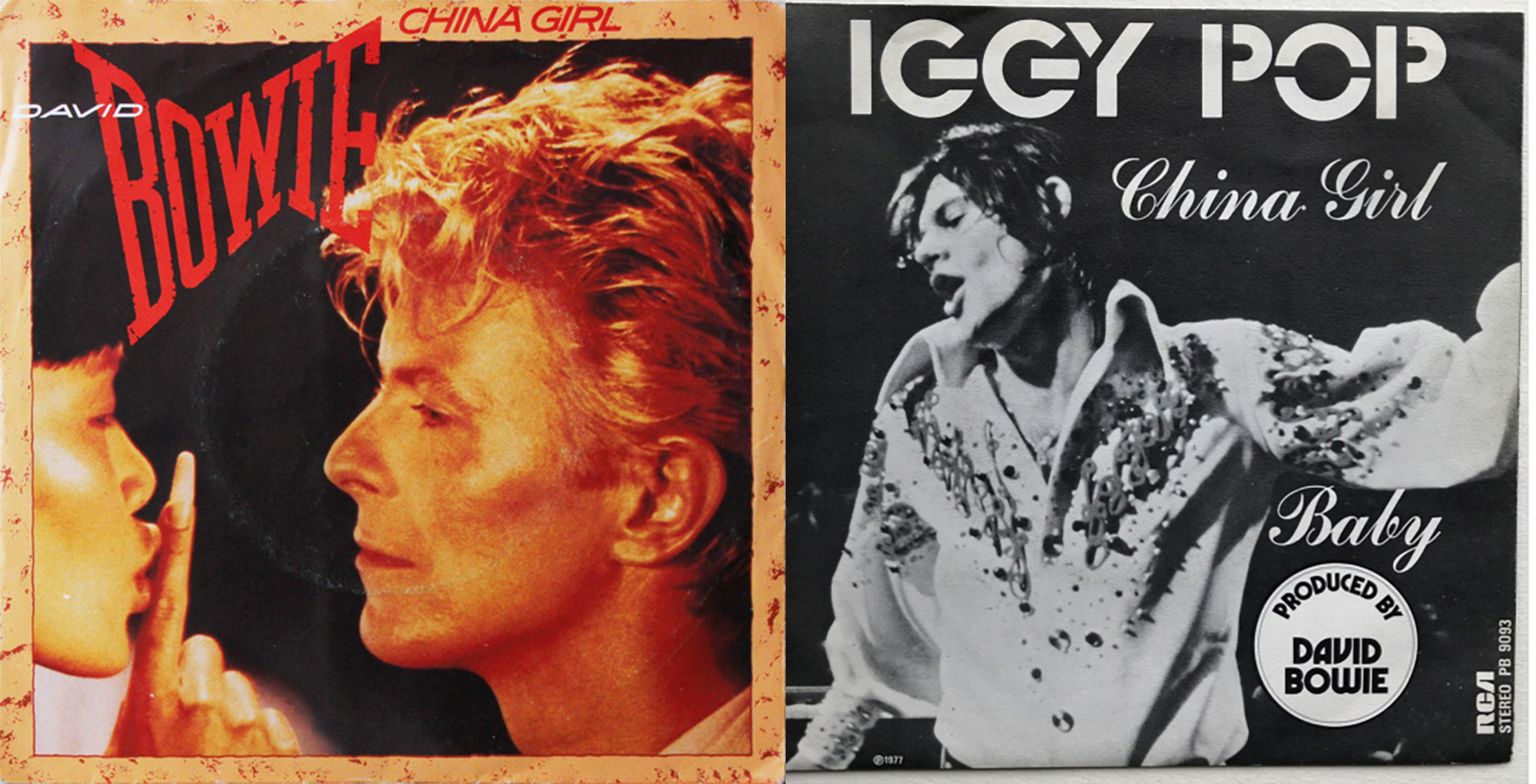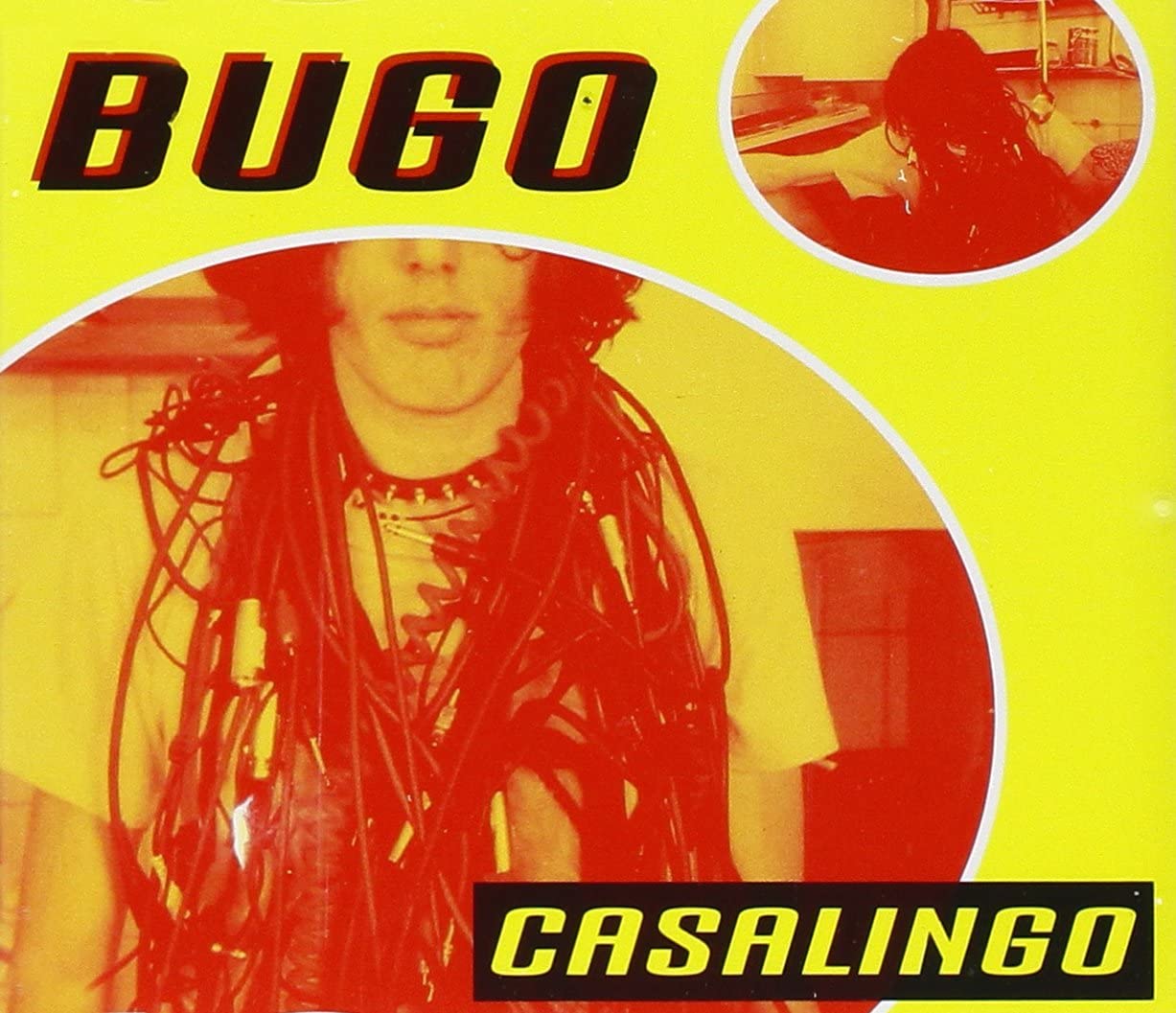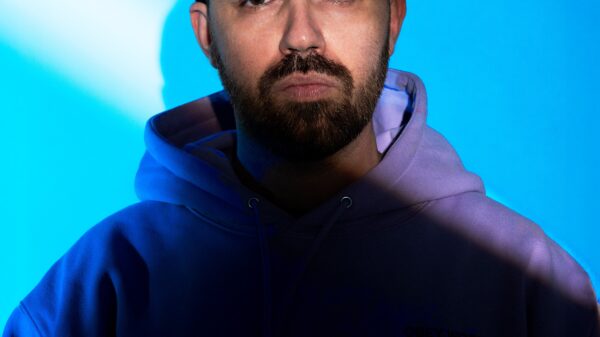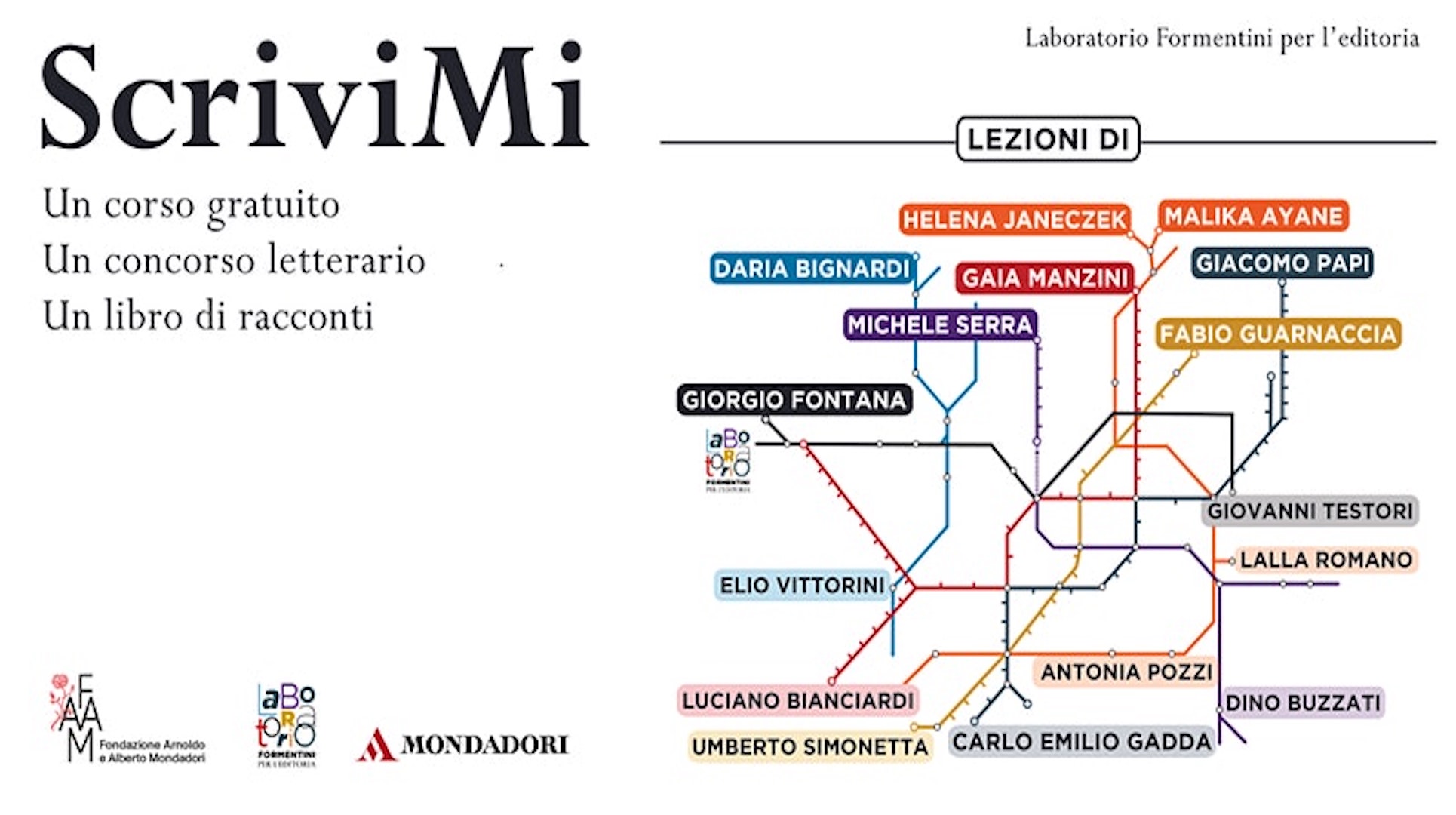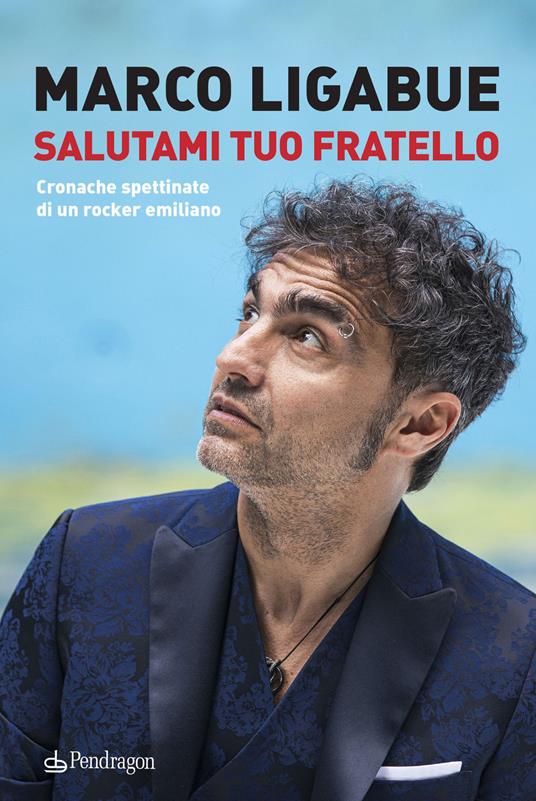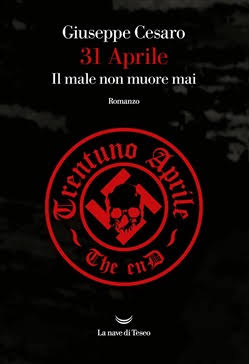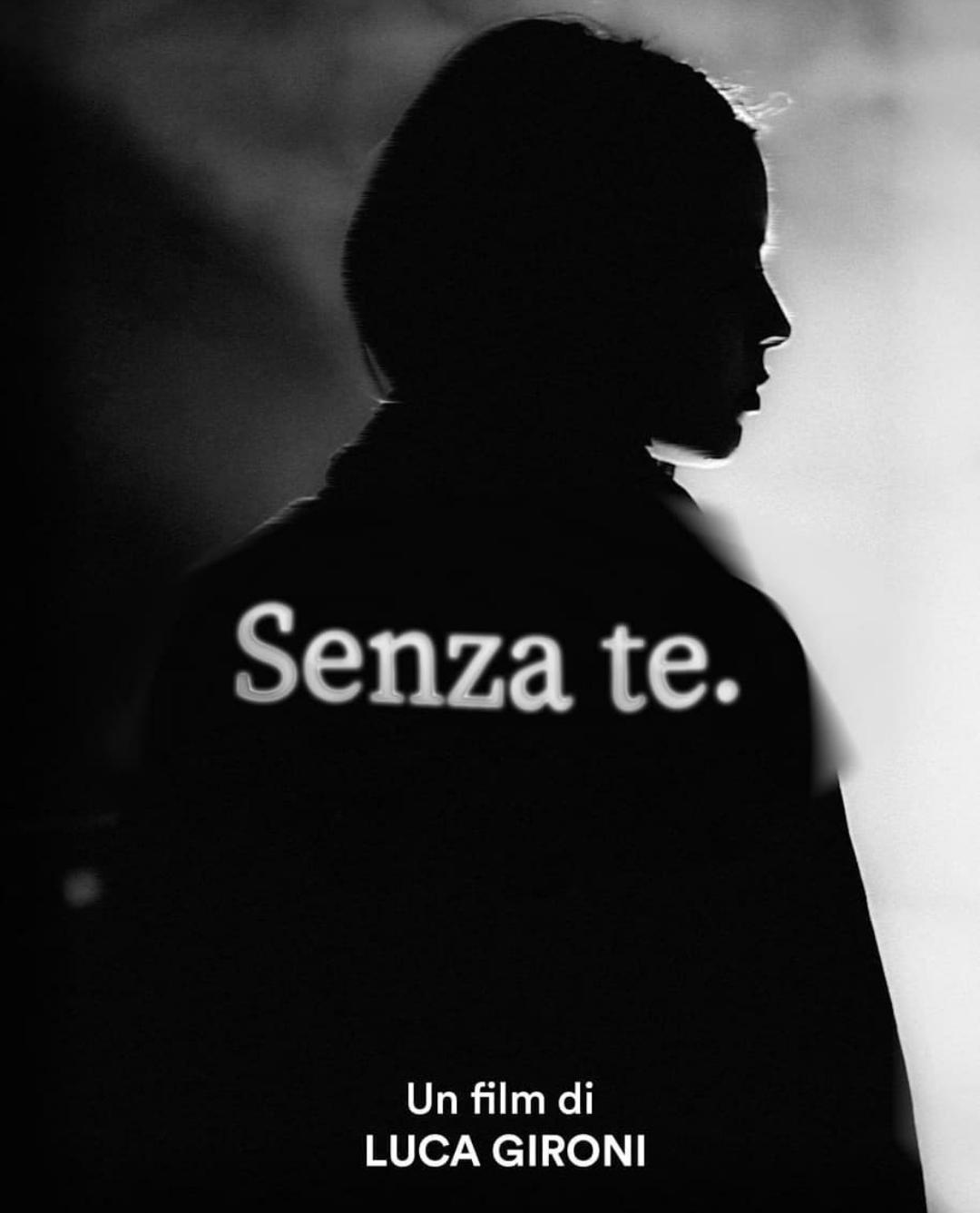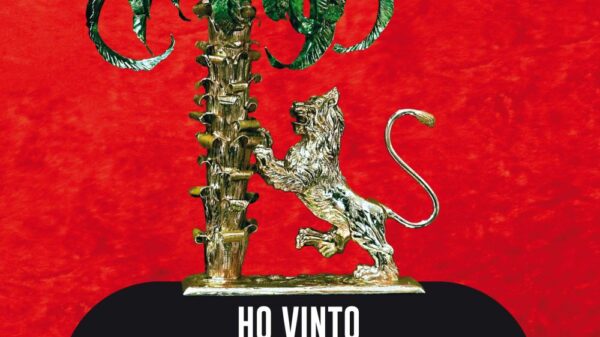Nel 2003, all’esame di maturità, scelsi il tema “E’ ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa?”. Ne seguì un articolo di cinque cartelle, dedicato al bisogno inspiegabile e incurabile dell’uomo di tendere al bello con tutto se stesso, a partire dalla parola. E la poesia è una forma esteticamente appagante della lingua. Qualsiasi cosa significhi forma, qualsiasi cosa significhi estetica.
Dovessi riscrivere il tema oggi, a 34 anni, dopo aver letto centinaia di post, tweet, romanzi, saggi, Catalano e Merolli, non mi fermerei qui. Dedicherei altre cinque cartelle all’amore.

Non rinnego nulla. L’uomo ha bisogno di percorrere le coste frastagliate del dolore e di aggrapparsi, subito dopo, a forme linguistiche che lo facciano sentire tre centimetri più alto delle proprie piccolezze. Ma non solo. Ha un profondo, viscerale, ancestrale e inestinguibile bisogno d’amore.
E’ l’amore l’obelisco indecifrabile attorno al quale l’essere umano danza per tutta la sua esistenza.
Come dimostra “Poesie per un Amore Inesistente” (Lupi Editore), per parlare d’amore nemmeno oggi basta la canzone. Occorre un flusso espressivo che, nella sua nobiltà, riesca a disegnare traiettorie precise e rappresentazioni grafiche. Lasci segni scientificamente interessanti sopra, con la consapevolezza di essere troppo fragili per poter dire tutto.

Riccardo Merolli, in linea con tanti autori contemporanei, rifiuta le regole compositive tradizionali e lascia che la penna spazi. Ogni poesia è una stanza e, in ogni stanza, si siede in un punto diverso.
Sembra paradossale, ma “Poesie per un Amore Inesistente” parla di un amore che esiste: diventa inesistente, in senso lato, nel momento in cui ci accorgiamo che accomuni tutti.
Parla di un amore possibile nella società delle comunicazioni di massa.
L’amore di un uomo, che prende il treno all’ultimo secondo
viene a trovarti
in quella città chiamata Amore Finito.