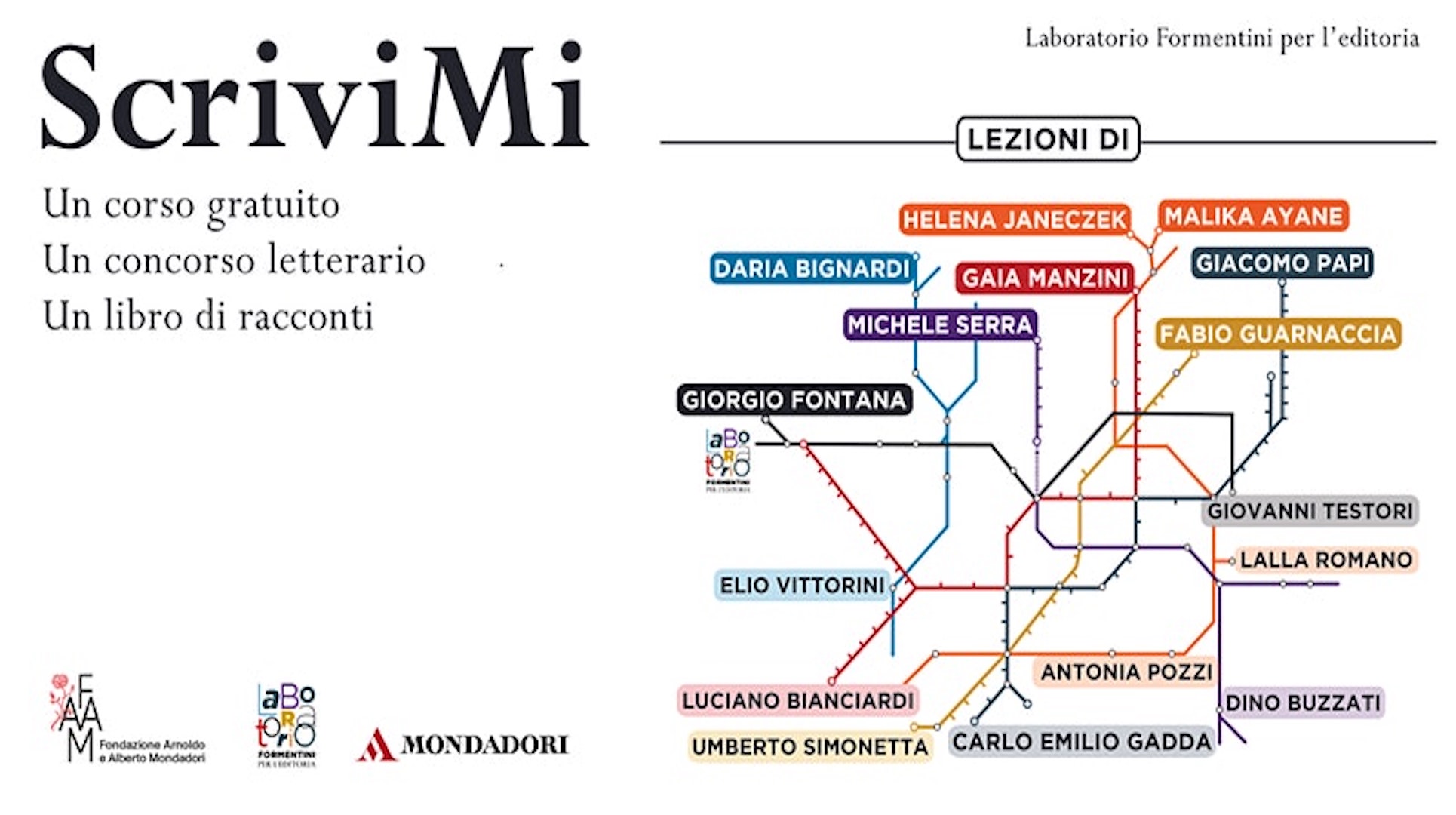Qualche tempo fa mi sono scontrata, un po’ per caso, un po’ per fortuna, con un disco che mi ha colpita in pieno con la sua delicatezza. Si tratta di Scansadiavoli, terzo album del cantautore parmense Rocco Rosignoli. Insieme a quest’ascolto è nata la curiosità di entrare in punta di piedi nel mondo di quest’artista, ed è così che ho scoperto che è un polistrumentista (eccellente con gli strumenti a corda), un compositore di musica per spettacoli e colonne sonore, appassionato di gatti, Leonard Cohen e Dylan Dog.
Mi sono fatta raccontare qualche capitolo della sua storia.
 Rocco, la tua è una storia di passione musicale, storica e sociale che si racchiude nella tua professione di musicista. Quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada?
Rocco, la tua è una storia di passione musicale, storica e sociale che si racchiude nella tua professione di musicista. Quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada?
Verso i vent’anni. Frequentavo l’università, qui a Parma, ma coltivavo amicizie soprattutto al di fuori della facoltà. Alcuni tra gli amici di allora scrivevano canzoni, come me. Ci ascoltavamo a vicenda, ci davamo consigli su ascolti e letture. Con uno di loro, Attilio Poletti, mettemmo su il primo gruppo con intenzioni serie, “I Preadamiti”. In quel periodo studiavo privatamente violino, e avevo iniziato ad approfondire la conoscenza dell’armonia. Il gruppo non durò moltissimo, ma mi diede modo di sperimentare le cose che stavo imparando, scrivendo i miei primi arrangiamenti. Contemporaneamente ero entrato nell’orchestra di plettri “I mandolinisti di Parma”, altra grande palestra e occasione di crescita e confronto, per uno come me che era stato essenzialmente autodidatta per molti anni. Dato che il mandolino ha l’accordatura del violino e dimensioni simili, e che si suona con tecnica chitarristica, non era stato difficile per me imbracciarlo. Poi iniziai a dedicarmi ai miei concerti e alle mie canzoni, finché a un certo punto non arrivò la proposta del maestro Riccardo Moretti, che mi voleva alle corde nel suo Gan Eden Ensemble. Quello fu il momento in cui quello di musicista divenne per me un lavoro, e da lì non smise più di esserlo – anche se per molto tempo ho fatto anche tutt’altro, dalla guida museale all’insegnante di italiano (ho fatto lettere) al barista.
Sei un polistrumentista che, nello specifico, suona strumenti molto particolari, quali bouzouki, mandolino, violino, oud arabo, oltre ovviamente alla “classica” chitarra. Da cosa deriva questa passione per gli strumenti a corda?
Lo studio della “classica” chitarra, o meglio della chitarra classica, l’ho intrapreso quasi per caso. Come molte famiglie, la mia aveva in casa una chitarra, che però nessuno suonava. A dieci – undici anni volli imparare a farlo io. Tra le mie grandi fortune c’è quella di avere una famiglia che mi ha sempre appoggiato in tutto, e mia mamma mi iscrisse a una scuola di musica. Lì mi diedero le basi del chitarrismo classico, che lì per lì non avevo gli strumenti per capire, ma delle quali a distanza di anni scoprii tutta l’utilità. Tra me e la chitarra non c’è stato un amore a prima vista, piuttosto per molti versi una relazione di comodo, che poi nella maturità è diventata un amore vero. La scintilla della passione invece è scoccata col violino, che avrei sempre voluto suonare, ma che, come dicevo, iniziai a studiare che avevo già ventun anni. Da lì non so, qualcosa deve essermi sfuggito di mano, perché nell’arco di tre o quattro anni la mia stanza si riempì di strumenti a corda. Amo tantissimo quelli che mi costruì mio zio, una delle persone che ho amato di più. Era un falegname, che in pensione prese a dedicarsi alla liuteria. Oggi non c’è più, ma suonare i suoi strumenti me lo fa sentire vicino. Mi ha costruito un mandolino napoletano dalla pala scolpita in maniera sublime, e un bouzouki dal suono splendido, che uso sia in studio che dal vivo.
Tornando un attimo alla questione “musicista di professione”, mi piace molto pensarci come un “self-made musician”, che è un po’ una definizione da sogno americano, ma che secondo me ti calza a pennello. Per riuscire a vivere di musica, infatti, oltre ad essere un cantautore, tieni lezioni di chitarra, componi musiche per documentari e spettacoli teatrali, accompagni una serie di altri musicisti. Riesci, in tutto questo, a rimanere fedele a te stesso e al tuo modo di essere artista?
Quello è il fondamento di tutto. Se il piatto fosse ricco, uno potrebbe anche pensarci, di recitare una parte e abbuffarsi finché può. Ma la trippa è ben poca, oggi, nel mondo della musica. Se non si può essere artisti nel modo in cui lo si desidera, conviene piuttosto far tutt’altro!
 Parliamo di Scansadiavoli, il tuo ultimo disco. E’ un’opera minimalista, costruita solo sull’uso della tua voce e della chitarra acustica. In un’epoca in cui si tende a coprirsi e a cumulare (non solo in ambito musicale), come è stato mettere a nudo la tua essenza?
Parliamo di Scansadiavoli, il tuo ultimo disco. E’ un’opera minimalista, costruita solo sull’uso della tua voce e della chitarra acustica. In un’epoca in cui si tende a coprirsi e a cumulare (non solo in ambito musicale), come è stato mettere a nudo la tua essenza?
In un disco non sei mai a nudo. Se una cosa viene male, la rifai daccapo. Una buona esecuzione di un brano magari è la quinta che hai fatto, e le altre quattro erano da buttare. Dal vivo, è lì che sei a nudo – soprattutto se, come me, un po’ per scelta e un po’ per forza ti trovi spesso sul palco da solo con la chitarra. Lì quella di rifare è un’opzione non contemplata, e tutto è così com’è esattamente nel momento in cui avviene. Un disco invece si tramanda, o almeno lo si fa con quella speranza, e quindi va tenuto sotto controllo. Certo, poi ciò che è contenuto nel disco è esattamente ciò che ho suonato, così come l’ho suonato, senza ritocchi di postproduzione, senza tagli o incollature, ma è il risultato di un lavoro pregresso. Scansadiavoli è un disco minimale nell’organico che lo esegue, ma è molto pensato, molto arrangiato, pre-prodotto con un lavoro di prove durato mesi, registrato in un ambiente molto particolare… e alla sua realizzazione hanno partecipato in parecchi, a partire da Ribamar Poletti che mi ha seguito in preproduzione e in registrazione, passando per Francesca Ferrari che mi ha seguito mentre studiavo i brani, Francesco Pelosi che mi ha costruito la scaletta, per arrivare fino a Martina Achilli che ha fatto foto e grafica… in realtà è paradossalmente uno dei lavori più collettivi che ho fatto!
Scansadiavoli è un titolo emblematico, che mi fa pensare a una sorta di amuleto, da tenere sotto al cuscino, per proteggerci dai nostri demoni personali. Queste canzoni ti hanno aiutato ad esorcizzare ed allontanare i tuoi?
Ho sempre cercato di non usare le canzoni come autoterapia. È un aspetto che certamente esiste, ma pensare la scrittura in questi termini mi sembra riduttivo… non fosse altro che perché la si piega a un’utilità. Scrivendo solo per curarmi, mi sembrerebbe di fare un torto all’atto artistico in sé, e a quello altrui. Se prendo la mia esperienza, e con lei i miei demoni, e ne faccio il materiale di cui canto, non è perché questo mi fa star meglio, ma perché son le cose che conosco. Ma se quest’esperienza non l’avessi elaborata a monte, scriverne mi sarebbe stato impossibile. Per fare un esempio concreto, c’è un brano, che si chiama proprio I Diavoli, che parla di un periodo molto buio della mia vita, ma che ho scritto molti mesi dopo che ne ero uscito. Ho preso un’esperienza emotiva e l’ho trasformata in un’esperienza estetica; e quando la canto cerco ogni volta di darle una nuova forma emotiva, che (si spera) si incarna nel pubblico che la ascolta. Per quel che ne so io il mio lavoro finisce lì.
Quali sono le tue fonti d’ispirazione più significative (letterarie, musicali, sociali, …)?
È sempre difficile restringere il campo… c’è tutto un panorama di canzone d’autore a cui sono profondamente devoto. Il primo cantautore che ho amato è stato Guccini, un amore che è iniziato con l’infanzia. Poi ne sono arrivati molti altri, da De André a Bob Dylan a Max Manfredi. Leonard Cohen rimane probabilmente il mio preferito in assoluto, ma amo Nick Cave, Jacques Brel, ultimamaente il meraviglioso cantautore scozzese Robin Laing, poco noto in Italia. Ma ascolto anche molta musica cosiddetta classica, prediligo Beethoven, Vivaldi e Schubert – ovviamente anche Bach. Come lettore ho letto davvero tanto, e disordinatamente. Tanta prosa, tanta poesia, tanti fumetti. Eugenio Montale è stato per anni il poeta che ho amato di più, ma anche Catullo, Lucrezio, Georg trakl, Hans Magnus Enzensberger… per non citare poi i classici, da Dante al Tasso passando per Ariosto. In prosa ho letto di tutto, da Petronio a Bukowski. Parlando di fumetti, poi, amo tantissimo Tiziano Sclavi, uno dei pochi autori che riescono a prendermi immediatamente sul piano emotivo; ma anche Alan Moore, che reputo uno scrittore di dimensioni epiche, e il fantastico Will Eisner. Negli ultimi anni ho letto soprattutto saggistica o letteratura di divulgazione scientifica.
E poi c’è una fonte d’ispirazione importante, che è un luogo: si tratta di Berceto, paesello dell’appennino parmense, di cui la mia famiglia è originaria, e dove appena posso scappo al volo. Lì ho scritto molte delle mie canzoni. Probabilmente perché sono le rare occasioni in cui riesco a prendermi alcune giornate intere di quiete, senza dover saltare tra un impegno e l’altro!
Nel 2011 è uscito il tuo primo disco, Uomini e Bestie – una sinfonia dell’orrore, un concept album ispirato al genere horror. Ti va di raccontarci la sua genesi?
Fu una genesi un po’ particolare. Mi ritrovai a distanza di poche settimane a scrivere due brani, uno che parlava del diavolo per come appare nelle tradizioni orali, e un altro che parlava di una strega. Quello del diavolo non l’ho mai finito, ma due brani vicini nel tempo che affondavano le proprie radici in un immaginario che noi moderni definiremmo horror mi diedero l’idea di sviluppare il discorso facendone una vera e propria galleria di figure dell’orrore. Fu un lavoro lungo e che mi divertì molto. Per quel disco, come per il successivo, curai tutto. Dalla composizione delle canzoni agli arrangiamenti alle registrazioni. Solo per il mixaggio scelsi di affidare il materiale a mani ben più affidabili delle mie, quelle di Ribamar Poletti, che da allora in poi mi ha sempre seguito.
Una curiosità: avvicinandomi a te e alle tue opere, ho notato che c’è sempre una presenza significativa: il colore rosso. E’ solo una questione di gusto o c’è un valore particolare?
Semplice gusto, ma è quasi un’ossessione, anche le pareti della mia camera sono rosse – da più di dieci anni, in ognuna delle camere in cui ho vissuto. Mi appaga la vista. Non sarebbe casa senza il colore rosso e dei gatti.
Tre dischi per te imprescindibili?
Uh, tre son pochi… vediamo: The Songs of Leonard Cohen, che nella mia formazione ha avuto un ruolo capitale, e che ancora mi strega ogni volta che lo ascolto; L’intagliatore di santi di Max Manfredi, per ragioni affettive: è il primo disco di Max che ho comprato fisicamente, fino ad allora avevo solo scaricato i suoi mp3, perché i dischi non si trovavano; e poi ce ne vorrebbe uno di Guccini, anche se lì scegliere è più dura… come disco direi Signora Bovary; forse il Guccini che ha fatto storia è un altro, ma qui c’è un Guccini maturo, molto intimo e al massimo della sua forma come cantante.
Cosa c’è nel tuo futuro?
Nessuno è profeta, ma per ora c’è pianificata tanta musica dal vivo, parecchi allievi di chitarra, uno studio costante del violino, e un cammino con il Coro dei Malfattori, che da poco tempo mi hanno chiamato a dirigere in quel di Parma, che è la mia città. Per il prossimo disco non ho ancora idee, ma ormai lo so che arrivano dal contesto che ti circonda. La parte difficile è porsi in ricezione.