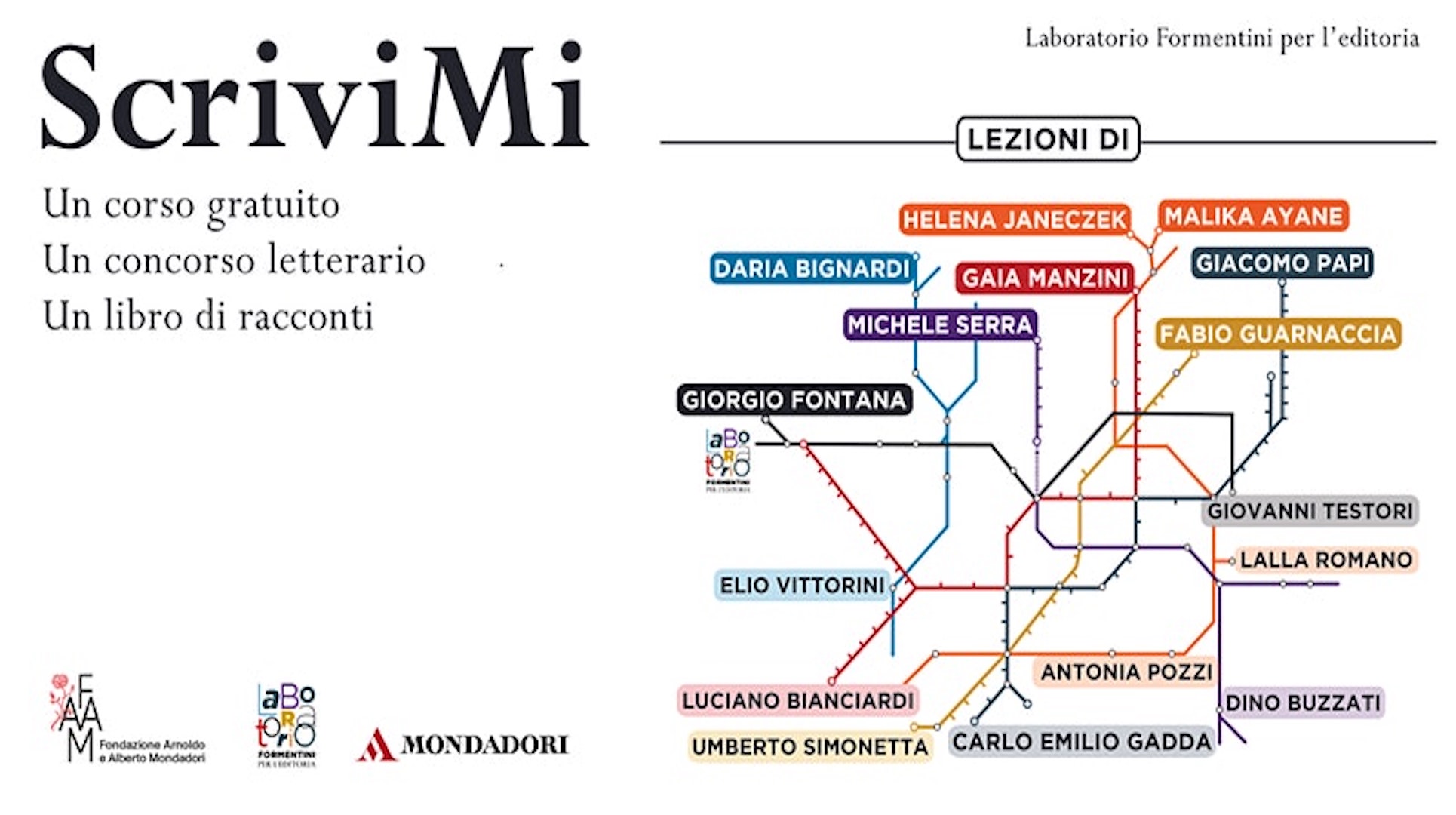Udde è un polistrumentista sassarese che il 31 marzo ha messo fuori il disco “The Familiar Stranger”. Il lavoro presenta note e vocalità oscure ma melodiche, facendoci viaggiare indietro nel tempo a cavallo tra anni Ottanta e Novanta. Le undici tracce riprendono la tradizione pop inglese mantenendo quella semplicità di racconto e vita raccontata.
Udde, mi evoca la tua origine sarda, cosa vuol dire e perché lo hai scelto?
Non ho scelto il nome per il significato che aveva, ma per il suono. Sicuramente ha diversi significati, dipende dalla geografia. Fondamentalmente volevo un nome tipo ABBA, ed Udde si avvicina.
Hai un passato musicale poliedrico ed interessante, quanto c’è di questo nel tuo presente?
Tantissimo, sicuramente. Con i componenti del vecchio gruppo facevamo a gara a chi scriveva canzoni con più accordi, e durante le registrazioni eravamo arrogantissimi, ed esageravamo con le sovraincisioni. La difficoltà che incontro nello scrivere canzoni semplici è senz’altro imputabile alle cattive abitudini del passato. Ma a parte questo, mi porto dietro gli ascolti, molti, eterogenei, e fondamentali.
Hai davvero buttato quello che doveva essere il tuo primo l’LP? Non c’è nulla di quello in “The Familiar Stranger”?
Ho davvero buttato (o messo da parte) tutto il materiale, in The Familiar Stranger non c’è niente. Il primo prevedeva più chitarre e basso, e, seppur campionata, la batteria sarebbe dovuta essere acustica, non una drum machine. Ma le risorse per poter registrare un disco del genere erano davvero scarse, e parlo sia di capacità di produzione sia di disponibilità economica per uno studio più professionale, con un acustica decente. Forse ho fatto il passo più lungo della gamba, ed ovviamente me ne sono reso conto in tremendo ritardo.
Ascoltando il disco, la tua voce e la musica mi danno la sensazione di essere a cavallo tra anni Ottanta e Novanta. Parlaci dell’album e di cosa ti ha ispirato nel comporlo.
The Familiar Stranger nasce tra il 2015 ed il 2016, con un pugno di canzoni scritte ad hoc in due settimane. Volevo registrare un disco con un approccio diverso rispetto al precedente. Potevo continuare con i suoni darkwave dell’EP Fog, che sono facili da gestire e talvolta richiedono un po’ di bassa fedeltà e riverberi con poco criterio. Ma a questo giro mi volevo concedere un po’ di semplicità, di rigore, e dei suoni pop. Volevo un disco che avesse un vestito di un certo tipo, e certe sonorità degli anni ‘80, un po’ decadenti, risultavano perfette. Nella composizione non c’è ispirazione, sono uno di quelli che si siedono al piano o imbracciano la chitarra esclusivamente perché vogliono scrivere una canzone, non perché sono stati particolarmente ispirati da qualcosa di tangibile o intangibile, o perché vengono lasciati dalla ragazza, o anche perché fuori piove ed il mondo è davvero un posto ingiusto. L’ispirazione forse arriva in sede di arrangiamento, ed è la canzone, il susseguirsi delle note, che ispira un certo determinato arrangiamento e la scelta dei suoni.
“One Heaven” racconta la storia di un italiano emigrato in Germania, è la tua storia? Ce la racconti?
Ahahah no, non sono io. Io sono un mezzo emigrato a Roma, nel senso che passo 6 mesi l’anno a Roma e 6 mesi a Sassari.
Durante un periodo in cui ero in Sardegna mi capitava di andare in un bar un po’ fuori città con degli amici. Nel bar c’erano sempre le stesse persone, ogni singola volta che andavamo. Uno di questi era un sardo pensionato che aveva sempre lavorato in Germania, lì si era fatto una vita, mettendo su famiglia. Ma lo trovavamo sempre lì. Ogni volta che apriva bocca lo faceva per elogiare la Germania, per far sapere a noi stupidi quanto si vive bene in Germania, e come lì tutto funzioni alla perfezione. Insomma la Germania come paradiso in terra. Però lui era sempre lì. Sempre in Sardegna. La famiglia in Germania, lui lì al bar in Sardegna. Era un quadretto perfetto.
Federica Monello