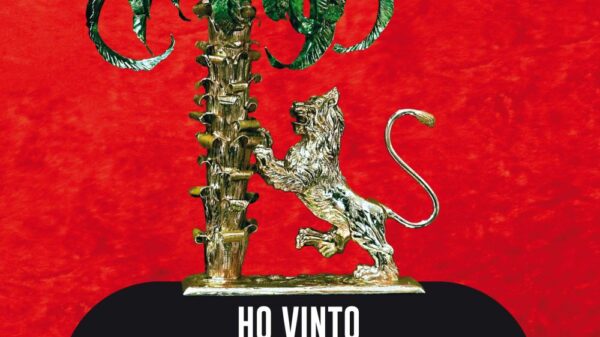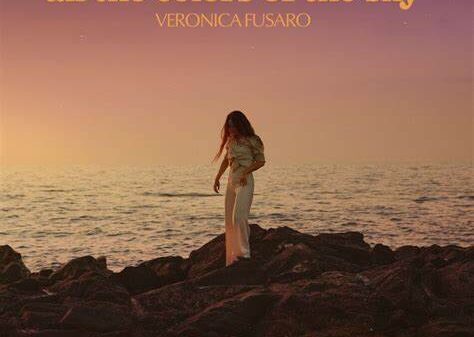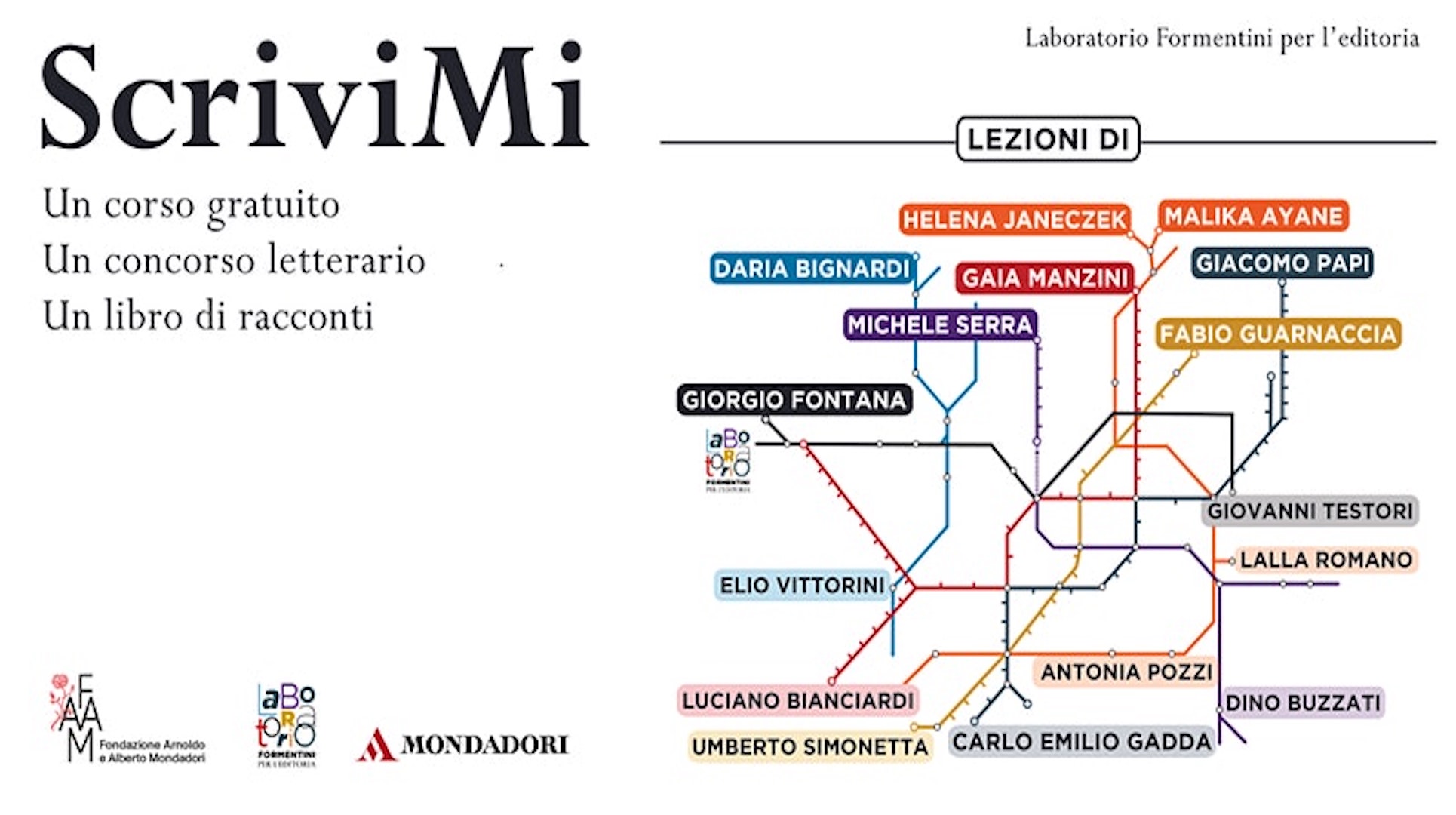Dobbiamo risalire al 2000, anno di uscita di “Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven” dei Godspeed You! Black Emperor per avere un metro di paragone, tra l’altro non italiano, che misuri la complessità di un album come “IRA”. A differenza dei canadesi, per i quali la realtà esteriore catturata nei field recordings è un fondale su cui rappresentare un dramma collettivo, con “IRA” Jacopo Incani fa risuonare voci interiori entro un alveo di inconscio magmatico ed oscuro. Il già notevole predecessore “DIE” viene adesso superato per ampiezza di visione e rifrazioni emotive, non solo per il monumentale impianto musicale, ma anche per lo sviluppo di una concezione della lingua, processata con una modalità tale da renderla strumento capace di fondersi con tutto il resto. Questa la differenza rispetto a “DIE”, che segna una profonda cesura rispetto a tutta la produzione precedente di Incani, ovvero l’abbandono definitivo dell’idea di cantautorato nel senso di allontanamento da ogni contesto di riferimento genealogico. La musica di “IRA” sembra derivare da un’altra dimensione, proprio in quanto scritta da un artista che ha cambiato pelle nell’anima e ha voluto cristallizzare la propria personale epifania.
Ogni cosa segna un punto di non ritorno, tale è il flusso di coscienza riversato tra le righe di una scrittura che si decostruisce all’infinito sino a diventare aliena. Parlare di richiami è un gioco degenerante e riduttivo, tale è la mole di elementi diversi elaborati nel corso di questi anni e confluiti nel progetto a nome Iosonouncane; la stessa forma canzone è destrutturata, sangue nelle vene di un corpo la cui carne trae sostanza dal misticismo di un entroterra immaginario e occulto. Il risultato è un enorme corpus magnetico che attrae con la sola forza della ieraticità delle sue strutture, generando creazioni immaginifiche attraverso una musica sostanzialmente indefinibile.
L’opener Hiver ha una mappatura genetica radiohediana per la capacità di tradurre il senso di smarrimento dello stare al mondo, la successiva Ashes si sviluppa su un tappeto di pulsazioni etno industrial alla Nine Inch Nails, Foule è una litania di trance desertica che però si dissolve in tenui umori vicini alla sensibilità di Apparat. Nuit è una ballata al piano avvolta in un bozzolo spleen di elettronica diafana (vedi anche Fleuve), mentre l’incedere marziale di Prison si muove con la solennità di un canto di liberazione entro un perimetro claustrofobico definito dalla scansione ritmica di Simone Cavina fino alla decompressione ambient di Horizon.
Sono proprio le escogitazioni armoniche l’elemento che colpisce più di ogni cosa, una latente sottostruttura pronta ad esplodere nel momento più inatteso, come nel finale da library music di Piel. Prière e Hajar costituiscono il viatico per l’avvento dell’irrazionale attraverso le formule di arcaici riti di passaggio, allo stesso modo delle preghiere a labbra serrate intonate dalle accabadore sarde, chiamate a fare cessare ogni sofferenza. Con la sua struttura circolare Sangre è pura spettralità ipnotica e Pétrole, traccia che ha una struttura più classica, rappresenta uno dei momenti più toccanti del disco con le sue derive post-rock. “IRA” parla di estinzioni, ma anche di continue trasformazioni lungo un viaggio in cui è necessario abbandonarsi a tutte le possibilità, compresa quella di perdersi. Disco da custodire idealmente nella mente e nel cuore.
Giuseppe Rapisarda