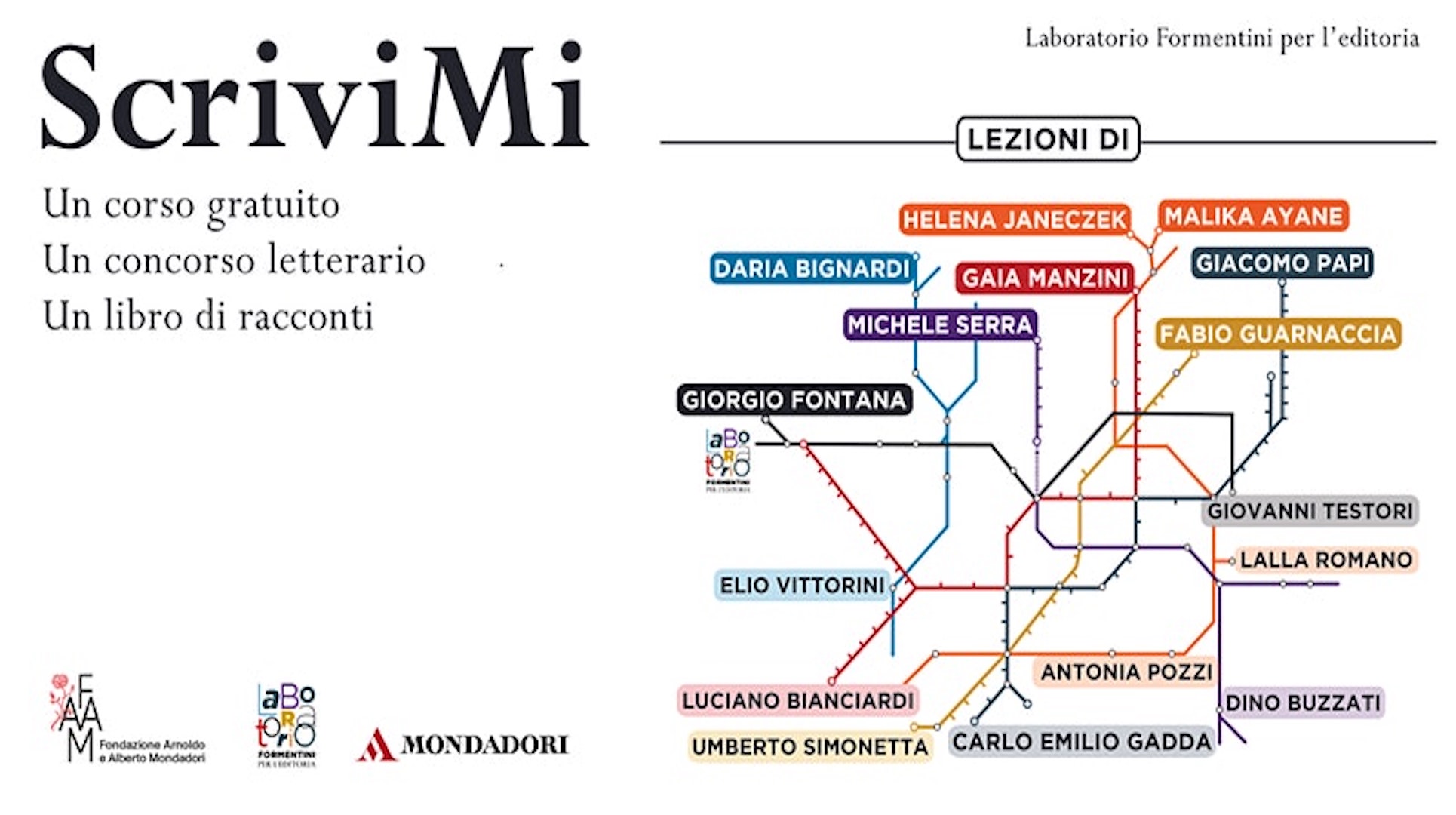Chiacchierata illuminante quella fatta con Mario Lo Faro, chitarrista dei Clustersun, band di Catania la cui musica non può semplicisticamente essere definita solo come “shoegaze”, considerate le innumerevoli influenze presenti in “Surfacing To Breathe”, album uscito lo scorso 19 maggio per la Seahorse Recordings. Con Mario abbiamo parlato delle dinamiche interne del processo creativo, degli ascolti metabolizzati nella loro musica, della scena italiana ed internazionale, nonché del rapporto tra la ricerca di qualità del suono in fase di registrazione e la graduale smaterializzazione di ogni supporto fisico.
A distanza di tre anni da “Out of your Ego”, il 19 maggio è uscito “Surfacing The Breathe” album in cui si avverte chiaramente una maggiore vocazione post punk e new wave, soprattutto nell’attitudine ritmica dei brani. Ci puoi spiegare quale differenza vi è tra i due album in termini di processo di scrittura e registrazione?
Il tempo trascorso tra “Out Of Your Ego” e il nuovo “Surfacing To Breathe” ci è servito per maturare un approccio ancora più organico ed espandere la nostra miscela di riverberi e muri di suono. Tre anni fa i brani erano nati con un piglio maggiormente etereo, sospeso e glaciale; la gestazione era avvenuta tutta tra sala prove e studio, e da qui deriva quel senso di equilibrio, controllo e pulizia, che oggi ci sembra probabilmente un punto debole, nonostante poi l’album sia stato recepito in maniera ottima, e ci abbia fatto conoscere ed apprezzare sulla scena shoegaze italiana ed estera. Con il senno del poi abbiamo commesso forse qualche peccato di inesperienza in sede di mix, assumendo decisioni in maniera troppo frettolosa e con orecchie non “riposate”. Le otto tracce in cui si articola “Surfacing To Breathe”, invece, sono caratterizzate da grande potenza e da un suono densissimo e muscolare, diretta conseguenza di una fase creativa che si è abbeverata del sudore e dei fragori del palco. I nuovi brani, infatti, sono stati composti ed elaborati in un momento di intensa attività live della band, a cavallo del tour americano del 2015: nel loro DNA c’è la dimensione della performance dal vivo impressa a fuoco. Ecco, la principale differenza tra “Out Of Your Ego” e “Surfacing To Breathe” sta proprio qui: tre anni fa avevamo concepito brani “da registrare”, mentre quelli di oggi sono decisamente “da suonare”. Forte. Fortissimo. A ciò va aggiunto che il processo di registrazione e produzione di quest’ultimo album è stato molto più meticoloso e curato. Le sessioni di ripresa, infatti, sono state condotte dal nostro tastierista Piergiorgio Campione allo Studio12 Recording di Catania, ovvero nel nostro spazio abituale delle prove e senza limiti di tempo, questo ci ha consentito un controllo totale ed efficace sulle tracce e notevole libertà in termini di sperimentazione. Il salto di qualità è poi avvenuto grazie al grandissimo lavoro svolto in fase di mix da Alessio Pindinelli (chitarrista e cantante de La Casa Al Mare, che ha anche coprodotto con noi il disco) e Fabio Galeone del Wax Recording Studio di Roma i quali hanno restituito una fotografia fedelissima del nostro sound e della nostra attitudine. La ciliegina sulla torta, infine, è stata il mastering effettuato da Carl Saff a Chicago, che ha magnificato il mix introducendo decibel, tridimensionalità e un livello di dettaglio davvero impressionante.
Quali sono le dinamiche interne della band in fase compositiva? Chi ha l’ultima parola sulle scelte degli arrangiamenti o vi è qualcuno deputato ad occuparsi di un segmento specifico della stesura di un brano?
Tutto nasce da lunghe jam session in sala, che registriamo regolarmente e nella loro interezza, per poi analizzarle a freddo. In fase di riascolto andiamo ad isolare le parti più interessanti e attorno a queste costruiamo e sviluppiamo il brano. Spesso si tratta proprio di frammenti brevissimi, o anche soltanto suoni ed effetti; in altri casi, come per magia, sono uscite fuori canzoni con una struttura già quasi definitiva. Non capita mai che qualcuno di noi arrivi con un brano già pronto, finora abbiamo sempre lasciato che le idee maturassero attraverso questo metodo di “brainstorming” musicale collettivo: la cellula originaria di ogni canzone, così, è sempre genuina e mai forzata, in quanto scaturente dall’interazione spontanea di tutti e quattro. Ognuno, poi, definisce la propria parte in autonomia, ma anche confrontandosi costantemente con gli altri, con un procedimento molto partecipato, in cui il contributo di tutti risulta sempre fondamentale per arrivare alla chiusura definitiva del brano. Dopo aver fissato la parte strumentale, è la volta dei testi, di cui si occupa esclusivamente Marco, efficacissimo nel tradurre in parole atmosfere che viaggiano in bilico tra melancolia, visioni oniriche e fragilità emotiva.
Nella vostra musica si sente l’influenza degli Slowdive nel loro versante più etereo, così come dei My Bloody Valentine per quanto riguarda l’assetto sonico della chitarra. Quali sono le band che più vi hanno influenzato? Ed oggi sei in grado di individuare una realtà veramente interessante nella scena italiana?
Sicuramente Slowdive, My Bloody Valentine e Ride sono un’influenza primaria per noi, così come The Jesus And Mary Chain, Swervedriver, Chapterhouse, The Brian Jonestowne Massacre, Spiritualized, Echo & The Bunnymen, Joy Division, New Order, The Cure, Spacemen 3, The Depreciation Guild, Neu!, Can. Tra i contemporanei sono grande fonte di ispirazione Ringo Deathstarr, A Place To Bury Strangers, Cheathas, Minor Victories, Flyying Colours, Pinkshinyultrablast, Nothing, Beach House, The KVB, Eagulls, Spectres, Preoccupations, The Black Angels, The Oscillation tra i tanti. A monte di tutto, comunque, tutti e quattro abbiamo allenato le orecchie fin da piccoli con Beatles, Pink Floyd e Velvet Underground. In Italia, per quanto concerne tutto ciò che è shoegaze, psych, dreampop, post-punk, wave c’è davvero grande qualità nella proposta, con tanti progetti validissimi come La Casa al Mare, Rev Rev Rev, Stella Diana, Novanta, Electric Floor, In Her Eye, My Invisible Friend, Be Forest, Soviet Soviet, Brothers In Law, Sonic Jesus, The Gluts, Arirang, Klam, Bialogard, Kimono Lights, Good Morning Finch, Weird., Leave The Planet, Jambox, The Yellow Traffic Light, 86Sandals, Purple Got Me Slow Mo, The Mystic Morning, Huge Molasses Tank Explodes, Human Colonies, Tiger! Shit! Tiger! Tiger!, Pipe’s Not Dead… e potremmo continuare ancora! Tuttavia questo bel fermento non sempre viene messo in risalto per come meriterebbe, all’interno dei confini nazionali. All’estero, invece, c’è decisamente molta più attenzione e la scena italiana viene ormai considerata come una fucina di talento rilevantissima e consolidata, al punto che ci si suole riferire ad essa con la definizione di “italogaze”.
Quanta parte vi è della vostra esperienza live maturata in questi anni nei brani del nuovo album?
Davvero tanta! I brani di “Surfacing To Breathe” non solo sono stati concepiti con il palco in mente, ma hanno avuto modo di essere quasi tutti rodati live per almeno un anno prima di essere registrati. Abbiamo quindi maturato una grande consapevolezza con riferimento ad ognuno di essi, di fatto usando i concerti come banco di prova ideale per sperimentare le soluzioni di arrangiamento più efficaci. La diretta conseguenza è stata quella di plasmare l’album in maniera da restituire quanto più possibile l’atmosfera, la potenza e l’impatto delle nostre performance dal vivo.
Dall’ascolto di “Surfacing The Breathe” si avverte una cura del suono, una ricerca di densità che passa attraverso non solo l’uso di strumentazione analogica ma anche dalla registrazione e dall’ottimo mastering dei brani che ne valorizza appieno le dinamiche. Cosa ne pensi della musica liquida e del tramonto del supporto fisico nella cultura delle nuove generazioni? Come giudichi, soprattutto in un genere come il vostro, la relazione perversa tra la cura nella registrazione di un disco con la compressione del formato digitale che taglia le frequenze ed elimina ogni sfumatura?
Fa tanto piacere che si noti la cura e l’attenzione profusa per aver un disco davvero ben suonante. In questo senso, cominciando dagli strumenti e continuando con amplificatori, effettistica, microfoni, banco, outboard, fino a giungere al mastering, ogni passaggio, ogni anello della catena di produzione di “Surfacing To Breathe” è stato gestito in un’ottica priva di compromessi, alla ricerca della massima purezza analogica del suono, che in generi come lo shoegaze e la psichedelia è un totem irrinunciabile. Siamo ben consapevoli, tuttavia, che, per buona parte, questa tensione ideale verso il buon suono sia condannata ad essere frustrata da ascolti dematerializzati, effettuati su formati digitali compressi che uccidono dettagli, sfumature, frequenze. È un buon motivo questo per rinunciare a preservare un suono di qualità a monte? Secondo noi no. Oltre ad essere, comunque, una naturale conseguenza del voler fare le cose al meglio, prima di tutto per noi stessi, siamo anche convinti che il gioco valga la candela, sempre e comunque. La musica liquida, infatti, pur nel compromesso al ribasso sulla qualità d’ascolto, racchiude in sé il pregio della estrema facilità nel raggiungere le persone: è portabile, può arrivare molto più lontano e a molta più gente, in un lasso di tempo praticamente nullo. Non va quindi vista come un nemico o un limite, anzi. Oggi essa costituisce il metodo più facile e frequente per approcciare una band o un artista e, in caso di sensazione positiva, spesso spinge l’ascoltatore più esigente alla ricerca del supporto fisico. Supporto fisico che è molto meno in crisi di quello che si possa pensare; basti osservare il trend in costante aumento delle vendite di vinili, che al netto delle pose da hipster, testimonia inequivocabilmente la crescente esigenza di un ascolto di qualità, sia in termini di suono, che di tempo dedicato alla musica.
Avete alle spalle un tour negli States. Come valuti il panorama italiano rispetto a quello d’oltreoceano, tanto con riferimento al feeling con il pubblico, quanto in rapporto con il mercato?
La differenza più evidente è che oltreoceano regna una curiosità e un interesse diffuso verso chi rischia con la propria musica, a prescindere dall’hype che un progetto può avere dietro. Che tu sia un artista affermato o un perfetto sconosciuto troverai comunque un’audience attenta e desiderosa di capire se vali, senza apriorismi o pregiudizi di sorta. Lo stesso valga per gli operatori del mercato discografico. Anzi, negli States è proprio palpabile la smania di scoprire la band ignota, magari prima che possa fare il grande salto: ne fanno un punto di vanto. Viceversa da noi, in mancanza dell’imbeccata dei blog, delle riviste o degli opinion leader “giusti”, è molto più difficile conquistare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori; sembra esserci un atteggiamento di fondo più pigro e condizionabile. Sono davvero tanti i casi di band che, come noi, si sono fatte notare e hanno consolidato la propria reputazione all’estero, non solo oltreoceano, prima di essere riconosciute con il giusto peso in patria.
Giuseppe Rapisarda