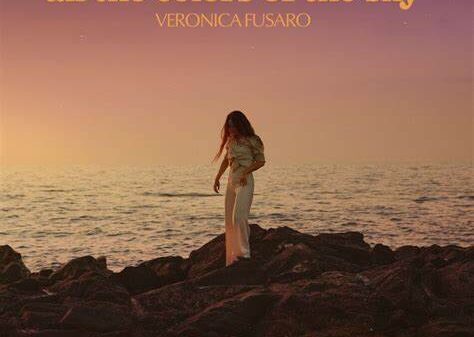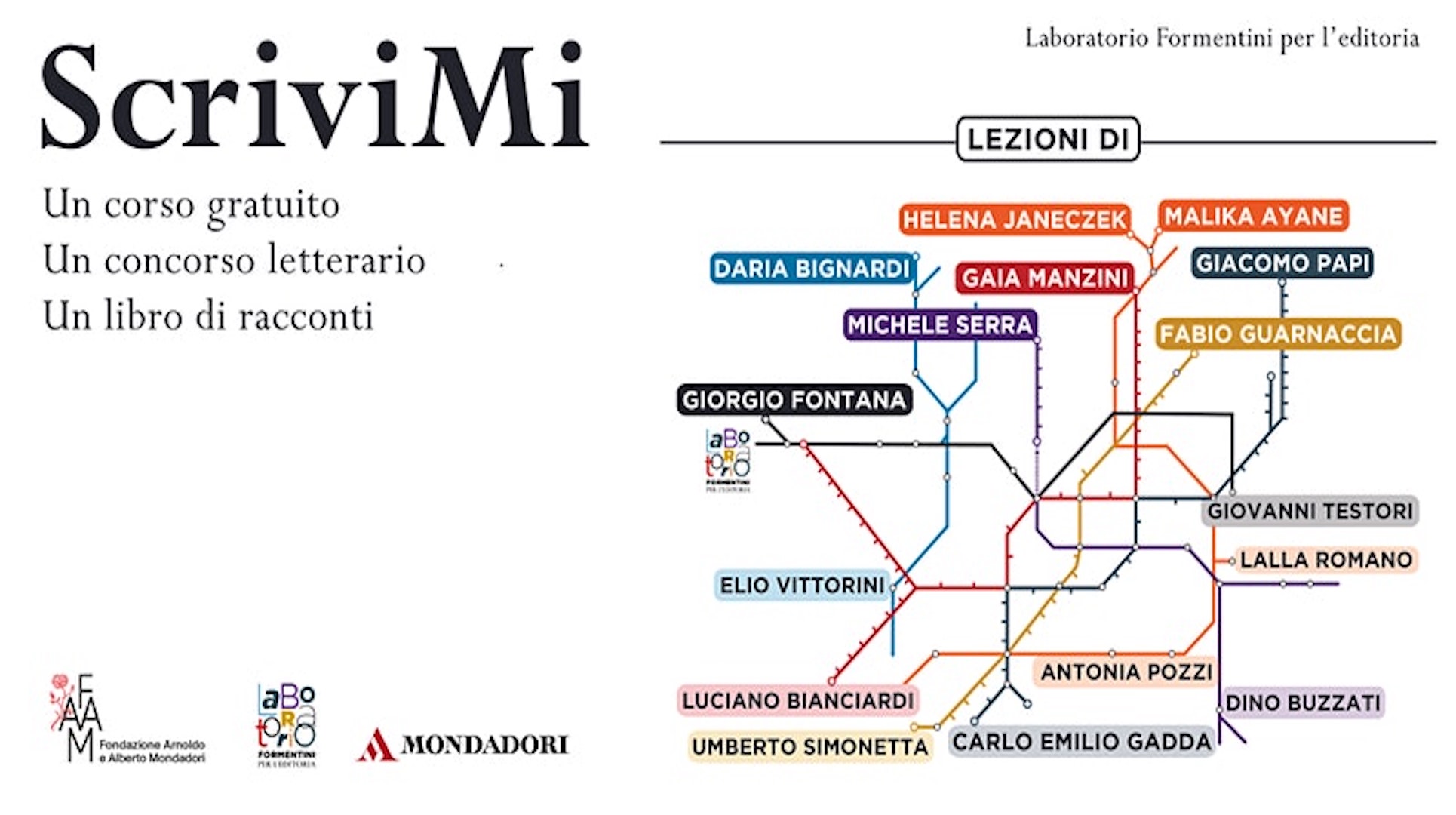Era il 2015, qualche mese dopo il concerto di Zafferana Etnea (CT) durante il tour celebrativo di “Hai paura del buio?”, quando la band decise di concedersi al pubblico catanese per due secret show di non più di duecento spettatori al Teatro Coppola di Catania. A distanza di poco più di due anni la band ritorna su quel palco per celebrare una corrispondenza di amorosi sensi con il pubblico e la scena catanese, donando se stessa attraverso una performance che si è tramutata in un rituale di appartenenza tra la forza emotiva di quelle canzoni e tutta la vita che l’ha attraversata. Tralasciando i primi tre album in inglese, tra la svolta di “Germi” ed il recente “Folfiri o Folfox” sono trascorsi più di vent’anni in cui tutto è cambiato, messo in discussione, solo per rimanere quello che già si era.
Mutuando il titolo di un libro-intervista di David Foster Wallace “Come diventare se stessi”, potremmo dire che gli Afterhours hanno compiuto nella propria carriera una immensa evoluzione circolare, tornando al punto di partenza solo per guardare le cose da una prospettiva diversa e per rivendicare la libertà di essere quel che si è. Ecco perché il concerto di Catania è stata la sintesi perfetta di maturità e potenza, dosate come elementi chimici di una combustione da cui è scaturito un fuoco in grado di illuminare il più nero dei cieli.
L’aria si è saturata di afrori elettrici già con l’opener Dentro Marilyn e poi con Strategie, doppietta micidiale di un inizio estremamente muscolare: Germi, Ossigeno, Il Sangue di Giuda sono brani incontenibili, nello spessore e nel volume, elemento che ha creato problemi dovuti all’impianto e ai limiti strutturali della sala. Nonostante ciò, il concerto non ha avuto inceppamenti di alcun genere, la macchina è rodata, procede spedita con Padania, Non voglio ritrovare il tuo nome, con l’avanguardia di Cetuximab e poi con Grande. Colpisce l’interplay e la complementarietà delle diverse sensibilità tra i due chitarristi Xabier Iriondo e Stefano Pilia, in cui le geometrie oblique del primo si fondono perfettamente con le ineffabili tessiture armoniche del secondo. Se Rodrigo D’Erasmo ricorda John Cale e Fabio Rondanini costruisce un incessante motore ritmico pulsante su cui si poggiano le linee di Roberto Dell’Era, Manuel Agnelli è il carismatico baricentro di un equilibrio perfetto, generoso nel suo non volersi risparmiare in brani che senza la sua voce sarebbero difficili da immaginare.
Ballata per la mia piccola iena, La sottile linea bianca e Pelle trascinano il pubblico con un’irruenza pari a quella di un fiume in piena. Il tempo di rifiatare e si ricomincia con La vedova bianca, Riprendere Berlino e Quello che non c’è. Impressionante la qualità media della scaletta, soprattutto quando il livello si alza con la parte riservata all’album “Hai paura del buio?” con Male di miele, Rapace e Voglio una pelle splendida. Dopo un’altra sosta arriva il momento di Bianca e Non è per sempre.
Gli Afterhours sembrano non voler smettere di suonare, rispondono ai richiami del pubblico che non li lascia andare via e loro si concedono ancora, prima con How We Divide Our Souls e poi con il dualismo sonico di La verità che ricordavo e Bye Bye Bombay. Ma c’è tempo per un’ultima canzone e con Ci sono molti modi la band saluta il suo pubblico. Le luci in sala si accendono, mentre le orecchie fischiano allineandosi alle frequenze di un cuore accelerato. Si stenta a prendere sonno perché si affollano pensieri di gioia e rivoluzione, alimentati dalla convinzione che, almeno tra i ricordi, questa sera sarà per sempre.
Giuseppe Rapisarda