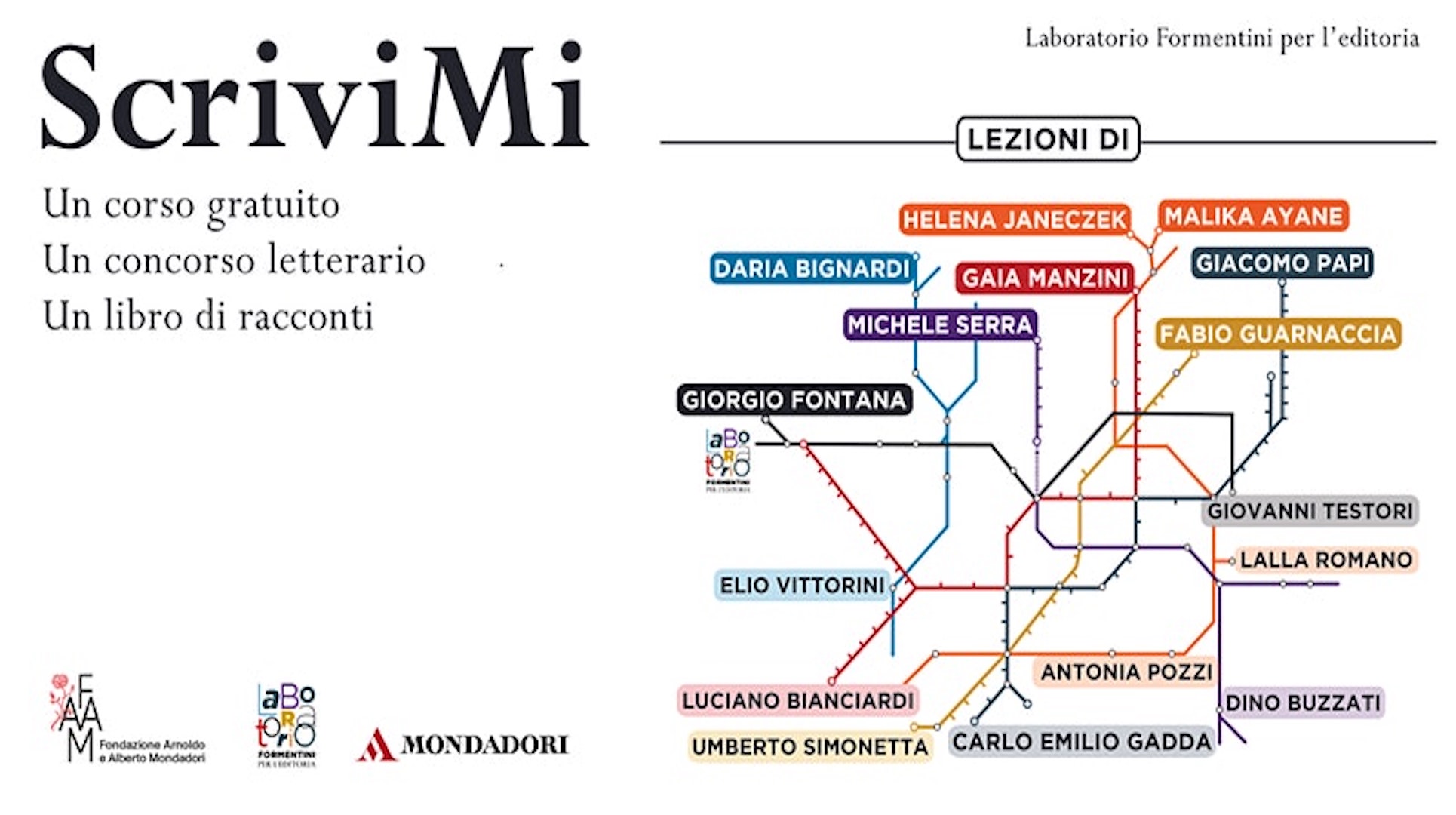Si chiama “Crack-up”, è uscito il 16 giugno di quest’anno ed è il nuovo album dei Fleet Foxes a sei anni da “Helplessness Blues”.
Il titolo prende il nome da una raccolta di saggi di Scott Fitzgerald del 1936, in cui l’autore indaga “sulle rotture”, cioè su quei momenti in cui una vita distrutta rinasce.
E già dal solo titolo si capisce bene che l’album prova a puntare contemporaneamente alla letteratura e alla musica, contaminandosi di entrambe.
E allora, volendo seguire il tono letterario del lavoro, si può dire benissimo che si tratta di flusso di coscienza musicale di 56 minuti, i cui testi compongono uno Zibaldone visionario in cui Robin Pecknold – il frontman e cantante del gruppo, che in questi sei anni di inattività della band ha frequentato facoltà di letteratura della Columbia University) – prova a mettere di tutto: dall’antico Egitto, alle filippiche di Cicerone e dalla guerra civile americana a Cassio l’assassino di Cesare.
L’album è complicato e molto strutturato e se da un lato il tono ermetico che pervade tutti i testi non si fa comprendere da chi l’ascolta, il sound dei Fleet Foxes è sempre avvolgente e sognante.
Il tono è sempre orchestrale, quasi solenne, e per descriverlo bisognerebbe parlare di movimenti più che di canzoni, visto che ogni traccia contiene perlomeno al suo interno tre o quattro variazioni talmente profonde da non essere neppure associabili le une alle altre.
L’effetto forse è quello di lasciare un po’ tutto nell’indistinto.
C’è difficoltà nel distinguere i vari pezzi, il che richiede uno sforzo notevole ed un orecchio allenato e sempre vigile a cogliere la tessitura certosina delle canzoni, che si mischiano, si confondono e rimano tra loro.
Insomma Crack-up non è un album accessibile a tutti e benché continui nel solco già tracciato dalla band, forse si spinge un po’ troppo in là con l’introspezione.
Il rischio è che l’ascoltatore si possa perdere nella pluralità degli strati che compongono l’album e se questa perdizione è, per molti che acquisteranno il disco, un effetto sperato, per altri rischia di essere l’anticamera della noia.
Nonostante tutto, il marchio di fabbrica è sempre quello dei migliori Fleet Foxes, armonie vocali da far vibrare i diapason e stupendi abissi musicali in cui l’ascoltatore sprofonda.
Il segno della continuità si vede anche nel nome del produttore Phil Ek, già Built to Spill, che ha accompagnato i Fleet Foxes in tutto il loro percorso e li prende sapientemente per mano anche col loro ultimo lavoro.
Andando ad esaminare le tracce si riconferma in pieno la continuità della band col proprio sound, anzi proprio di continuità bisogna parlare visto che il pezzo di apertura “I am all that I need/ Arroyo Seco/ Thumbprint Scar” è una vera continuazione di “Grown Ocean” (l’ultima traccia del loro precedente album). Il suono lascia sbalorditi, tanto che quando la prima cappella cede il passo alla potenza delle chitarre, si pensa che quello sia l’inizio di un vero capolavoro.
Subito dopo, invece, le aspettative si adeguano ad una realtà più modesta, ma comunque di qualità, il tutto nel segno di un’opera profetica e visionaria, in cui i Fleet Foxes provano a superare i limiti perfino del tempo.
“Third of May/Odaigahara”, il cui titolo deriva da un quadro di Francisco Goya, ne è un esempio perfetto.
Lo stesso Pecknold ha ammesso che già alla fine della prima parte del singolo, l’abbassamento di un’ottava nella sua voce (quando canta “Was I too slow / Did I change overnight”) indicherebbe “una voce che viene da un tempo successivo rispetto a quella che ha cantato la prima parte dello stesso pezzo.” Impossibile capirlo senza l’esegesi dell’autore, a testimoniare che si tratta di un album che per essere compreso davvero avrebbe bisogno di un piccolo manuale accanto.
“I Should see Memphis“, invece, sintetizza tutto l’approccio ermetico di Pecknold; approccio che a qualcuno potrà sembrare irritante e confusionario. Un esempio? Alla fine del pezzo dopo aver menzionato nell’ordine una una donna sibaritica, Cassio, Kinshasa ed il fiume Appomattox, scopriamo che la Memphis cui i Foxes si riferiscono non è la città di Elvis, ma l’omonima Menfi di Osiride, nell’antico Egitto. Una sorpresa certo, ma circondata da una specie di esotismo ridondante che traspare nei nomi ricercati che formano praticamente metà del testo.
Ecco, tirando le somme si può dire che di sicuro agli amanti del genere ed agli amanti dei Fleet Foxes questo nuovo album piacerà, ed oggettivamente è un album maturo e di ottima qualità, con il chiaro limite di non volersi aprire a chi lo ascolta.
Andrea Costa