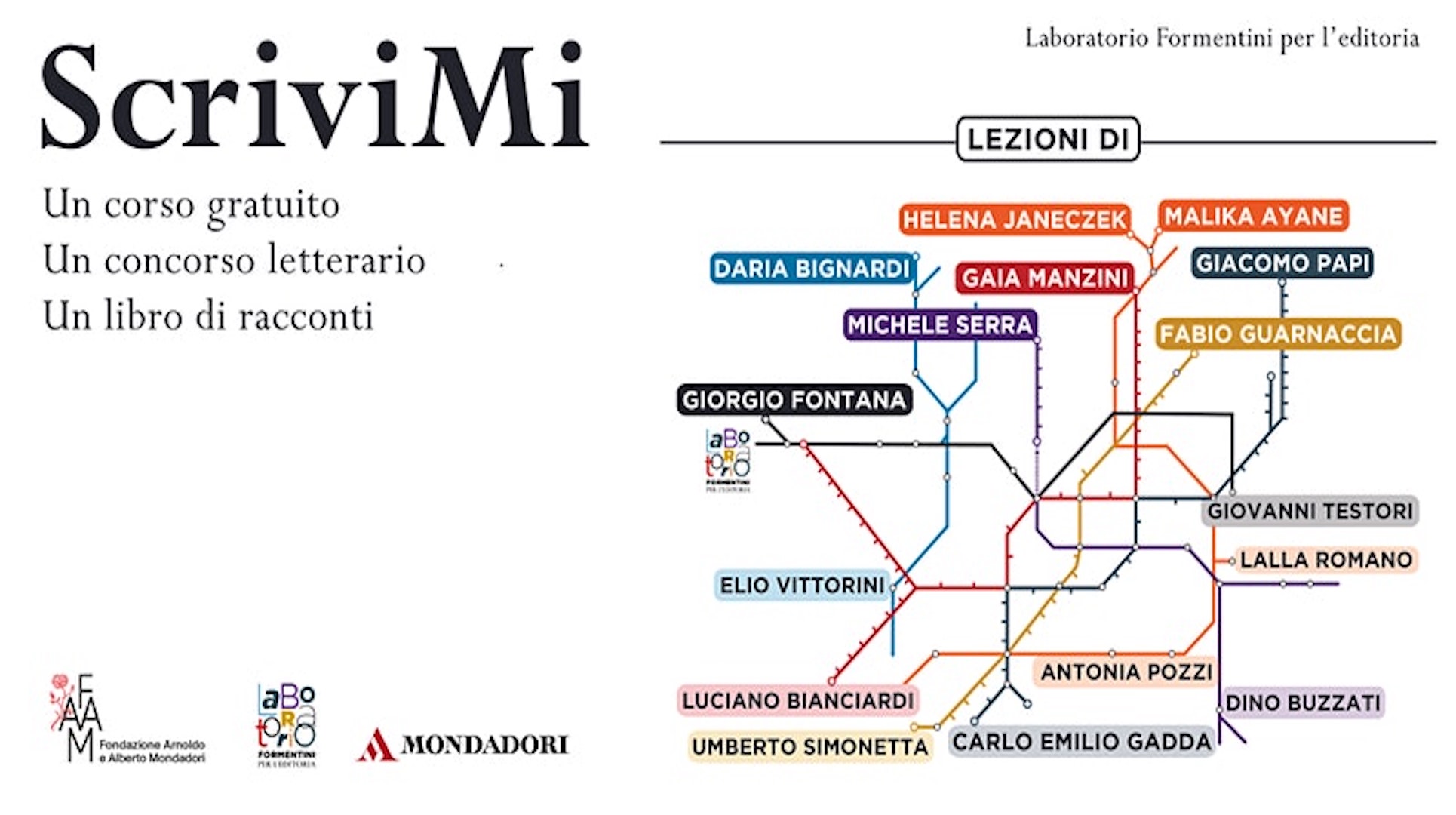When you speak, speak sincere
And believe me friend, everyone will hear…
Viso da bambino, fascino da poeta maledetto, Grian Chatten ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo volto dell’indie rock mondiale di questo decennio appena iniziato. Pubblicare un secondo album dopo un lunghissimo tour e il successo di “Dogrel”, disco che ha consacrato la sua formazione, i Fontaines D.C., in ogni angolo del globo attirando nuovamente l’attenzione internazionale sulla scena di Dublino, deve avere causato non poche preoccupazioni alla band, che sin dal primo brano ci tiene a precisare che no, non appartiene a nessuno e che nonostante il successo non vuole perdere quell’indipendenza artistica che l’ha portata nell’olimpo della musica.
Ed in effetti, brano dopo brano, ci rendiamo conto di come la formazione non abbia perso il suo smalto, ma anzi di come tutti quegli elementi che l’avevano resa unica e riconoscibile già dalle prime note del precedente lavoro ne risultino rafforzati. L’album si apre con una dichiarazione d’intenti, “I don’t belong to anyone”, dalla quale si dipanano tutta una serie di riflessioni sulla vita e sul mondo che ci circonda. La visione è più ampia del precedente lavoro, la band ha girato il mondo e il punto di vista non è più quello di semplici “Dubliners”, ma di rockstar navigate che ne hanno viste tante, forse troppe lungo la strada. Attenzione, però, a pensare che la band si sia montata la testa o si offra al pubblico con fare paternalista, anzi, leggendo i testi sembra che l’intenzione di questo secondo lavoro sia quella di tenere i piedi ben piantati a terra, sia musicalmente che come individui, cercando di condividere con l’ascoltatore sentimenti e ansie. La voglia di indipendenza tanto declamata nel primo brano si rintraccia anche nello stile compositivo del disco, dove la band dà il meglio partendo da quegli spunti di genialità di “Dogrel”, che vengono qui portati verso una visione più matura che non teme di allontanarsi dal post-punk, azzardando addirittura con le atmosfere rarefatte di un finale a sorpresa, che nessuno si sarebbe mai aspettato e che dimostra la versatilità della formazione anche su altri territori.
Questo secondo album è nato in tour, ma non sembra uno di quegli album scritti di fretta per cavalcare l’onda del successo. È chiaramente un album studiato, riflessivo, che pone l’amore sopra tutto, esprimendo con forza la malinconia di quello che si è lasciato indietro (A Lucid Dream, Oh Such A Spring), tipica degli album scritti in tour, mescolandola con la frenesia della vita on stage e con la voglia di prendere fiato e rallentare un po’ (You Said). A un certo punto azzardano anche lezioni di vita (A Hero’s Death), in quello che sicuramente può considerarsi uno dei pezzi più tirati dell’album. Gli ultimi due brani ci portano in un mondo completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto prima, è come se con questi pezzi il loro lungo viaggio si fosse concluso, giungendo finalmente a casa. “Sunny” è un pezzo immaginifico che ci fa vivere l’attesa di una telefonata, attesa che ci conduce alla riflessione finale contenuta in “No”, un dialogo con se stessi, di quelli che solitamente portano a un punto di svolta nella vita.
L’album si conclude così, lasciandoci con la curiosità di scoprire che ne sarà di questa storia e del futuro di una formazione su cui possiamo sin d’ora azzardare più di una scommessa.
Recensione a cura di Egle Taccia