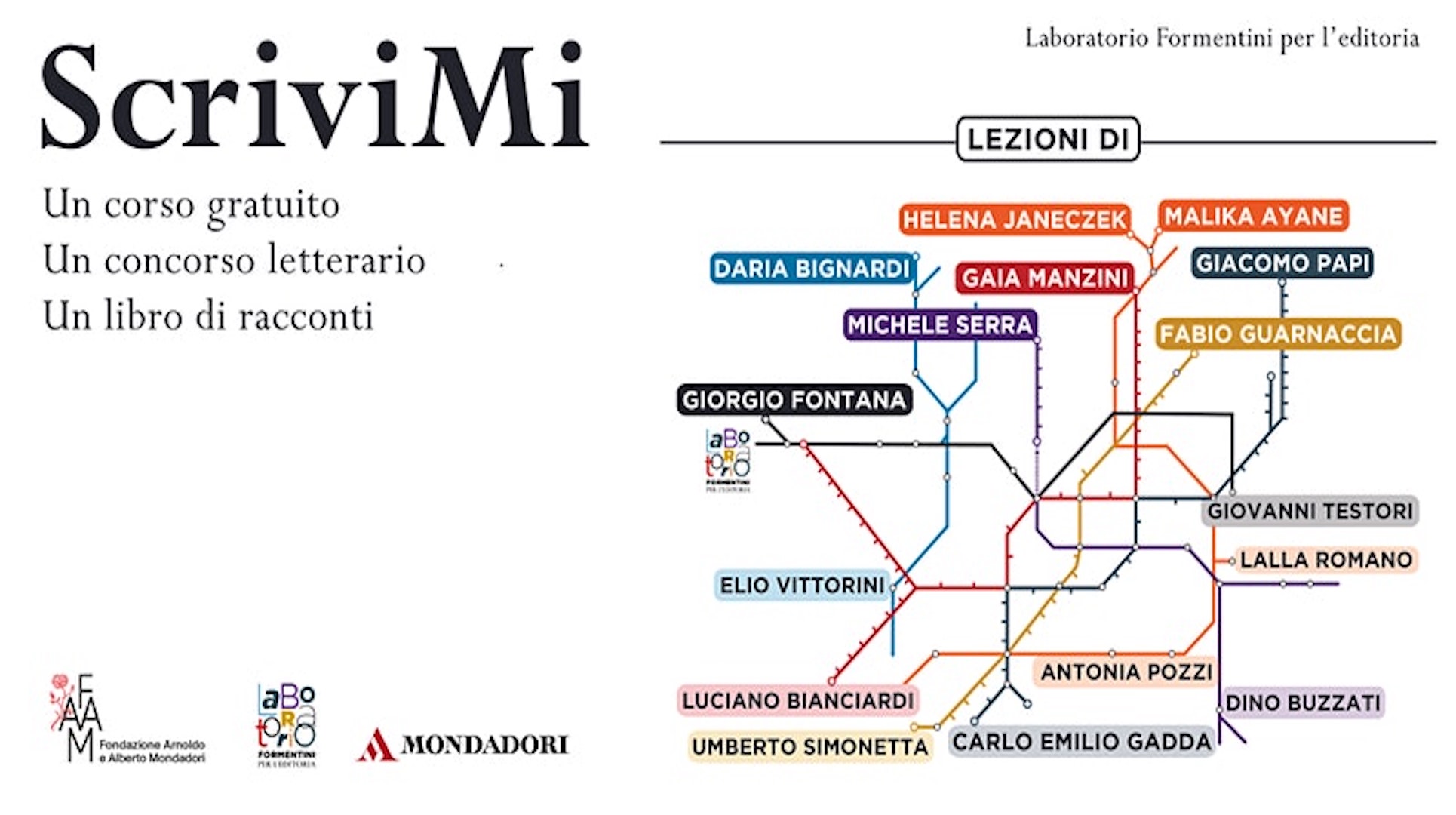Venti anni.
Scorrendo i credits di Every Country’s Sun, nona prova in studio per i titani del post-rock Mogwai, l’occhio cade distrattamente sul dato più ovvio, quello del corrente anno di produzione. Mi fermo un attimo e la mente corre indietro nel tempo ad un pomeriggio del 1997. Metto a fuoco un’immagine nitida, ma allo stesso tempo desaturata da una patina di piacevole nostalgia, invece che dal posticcio alone dei filtri di Instagram: c’è la mia scrivania da matricola universitaria, uno stereo compatto e due cd, Ten Rapid e Young Team, di un gruppo scozzese il cui nome evoca i Gremlins di Spielberg. Rivivo il momento della pressione sul tasto play e poi la pelle d’oca per quell’alternanza da brividi tra malinconici arpeggi e densissime tempeste di distorsioni: suite elettriche prive di melodie vocali, quasi delle sinfonie classiche declinate con l’arsenale del rock alternativo.
Svanito il ricordo, mi trovo a riflettere sul tempo trascorso da quel pomeriggio del 1997. In due decadi i Mogwai hanno articolato una delle parabole artistiche più solide e consistenti dell’intera scena indipendente, contribuendo a definire confini e modalità espressive del post-rock, per poi tentare di forzarne e dilatarne gli stilemi, schivando i rischi di una ritualità stantìa, ma conservando sempre una voce unica e riconoscibile, diventata essa stessa quasi genere autonomo. E oggi, ascoltando Every Country’s Sun, si ha la sensazione che Stuart Braithwaite e soci abbiano voluto tirare le fila della propria storia ventennale, compiendo una monumentale opera di riflessione e sintesi su se stessi. Il nuovo album, infatti, condensa praticamente tutto il bagaglio espressivo di strutture, atmosfere e suoni proprio degli scozzesi, ma ha il pregio di calibrarne le singole componenti con un livello di consapevolezza talmente profondo, da pervenire ad un esito di equilibrio e compiutezza quasi metafisico.
La dipartita del chitarrista John Cummings, già ben gestita nell’ottima soundtrack di Atomic, viene qui completamente metabolizzata anche grazie al ritorno in cabina di regia di Dave Fridmann. La mano che aveva plasmato il suono di C.O.D.Y. e Rock Action, due fra gli episodi in assoluto meglio suonanti nella discografia dei Glaswegians, orienta il timone della produzione nel senso di una maggiore muscolarità chitarristica rispetto a Rave Tapes, dove l’ibridazione elettronica era stata spinta al massimo. Fridmann, infatti, ha il merito di trovare un bilanciamento perfetto tra la furia angolare delle sei corde e le calde densità dei sintetizzatori, tale da conciliare l’anima hardcore dei Mogwai più risalenti con quella “synth-driven” delle ultime produzioni. Inoltre conferisce all’insieme una compattezza sonora che, unita alla qualità e varietà di scrittura dei brani, rende Every Country’s Sun un album quintessenziale nella sua eterogeneità.
Eterogeneità che emerge inequivocabilmente già in apertura di lavoro, con le prime due tracce. Il singolo Coolverine incarna perfettamente il ruolo di “macchina del tempo”, con un arpeggio che evoca la 2 Rights Make 1 Wrong di Rock Action per poi planare nel presente, sulle ali di una stratificazione celestiale di synth e accordion. Ma è con la successiva Party In The Dark che gli scozzesi sorprendono e spiazzano: una felicissima contaminazione tra New Order e Slowdive, frullato di post-punk e shoegaze che si abbevera dell’esperienza di Stuart con i Minor Victories (manca solo Rachel Goswell ad armonizzare sulla linea vocale, cantabilissima ed affogata in un oceano di riverbero reverse) e si caratterizza di sicuro come l’episodio più “catchy” di sempre nella discografia dei Mogwai.
Soffia ancora aria fresca con l’ambient delicato, ma livido, di Aka 47, con il gospel cosmico di 1000 Foot Face (entrambe sono permeate da uno spiccato Brian Eno “flavour”), con i synth solari e il drumming trip-hop della cinematica Brain Sweeties. Ma l’asticella si alza davvero nel momento in cui il quartetto distende i muscoli e si riappropria della sua potenza di fuoco, deflagrando in momenti di colossale ed epica magnificenza sonora, quasi a liberare un’energia che negli ultimi anni sembrava circoscritta e domata. Così il crescendo ostinato dell’abrasivo riff di Crossing The Road Material, che esplode incandescente come una supernova, è oro post-rock a 24 carati, blindato da un implacabile groove motorik. Ed in 20 Size riconosciamo la band di Young Team, con addosso ancora l’odore di Slint e Codeine.
Don’t Believe The Fife, poi, ridefinisce il concetto di pelle d’oca: la sua sezione iniziale, di raggelante solennità, sembra fermare il tempo e il cuore, prima di sfociare in una coda di pesantissima, abbagliante potenza: è uno dei vertici emotivi di questo album. Ed anche il viatico ideale per il micidiale uno-due di Battered At A Scramble (introdotta da una saturatissima bass line, grassa come il lardo di Colonnata) e Old Poisons (che richiama Bat Cat, ma dopo un’overdose di steroidi): un’orgia di fuzz, chitarre dissonanti e altri malefìci sonori assortiti caratterizza i due brani più minacciosi e impattanti dell’intero LP.
La tempesta, infine, si dipana per lasciare spazio alla title track, che chiude il cerchio in maniera straordinariamente coerente, fungendo da retrospettiva sull’album stesso e sulla intera parabola artistica dei Mogwai. È un brano che, nella sua ispiratissima, lirica e commovente evoluzione da sospiro fragile a cattedrale sonica, sussume alla perfezione i venti anni di vita e di musica della band e certifica la conquista di un equilibrio espressivo, formale e sostanziale, che diventa, allo stesso tempo, traguardo e punto di partenza per nuovi percorsi creativi.
Mario Lo Faro