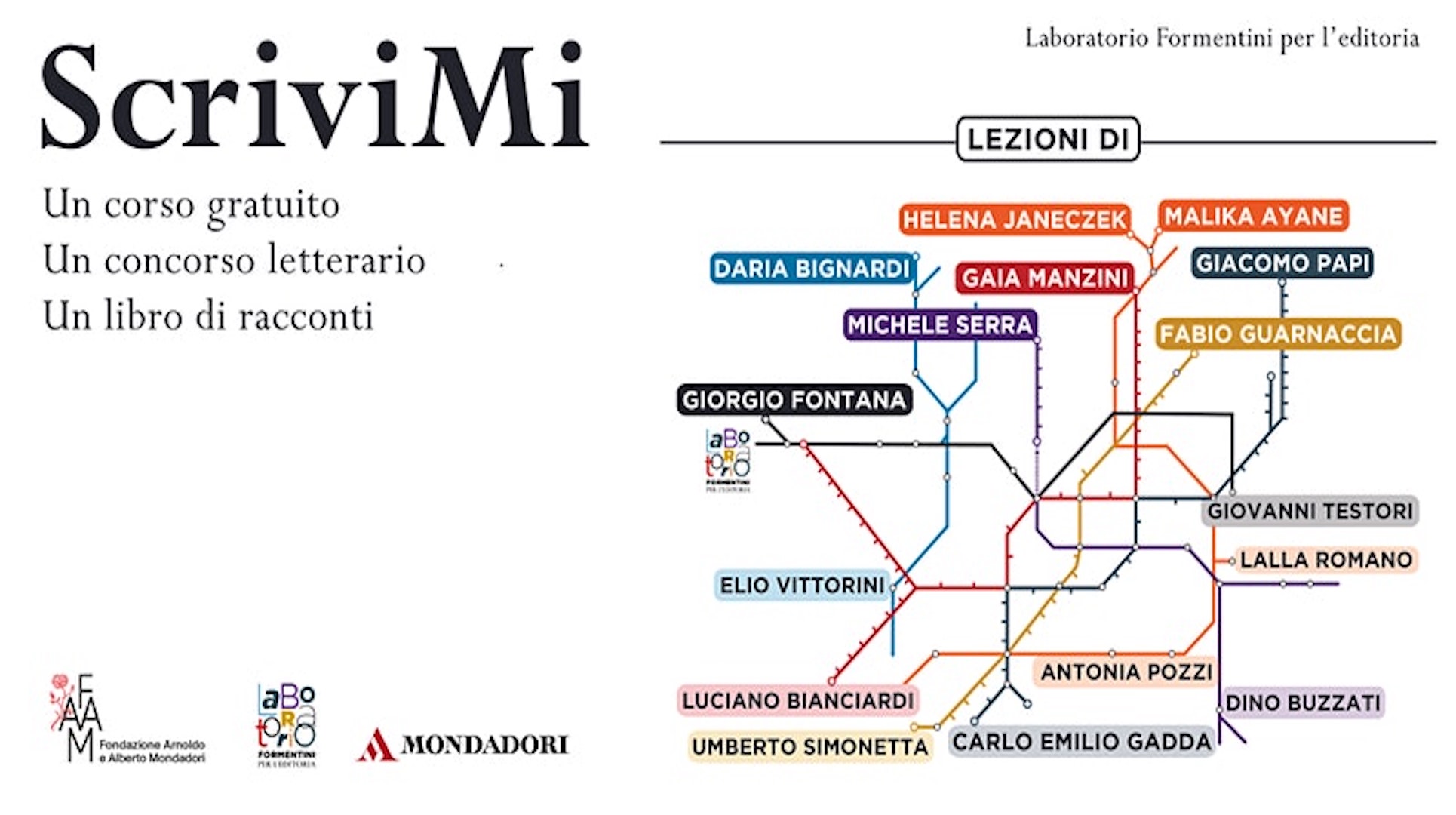E’ uscito da pochissimo Tales for digital bodies, l’album d’esordio degli U BIT, gruppo nato nel 2014 tra La Spezia e Reggio Emilia e formato da Giuseppe Vitale (voce) Claudio Buondonno (basso), Alessandro Messina (chitarra), Matteo Postorino (tastiere) e Paolo Meneghini(batteria).
Undici tracce che raccontano la condizione dell’essere umano nell’era digitale in cui viviamo. Il disco è stato arrangiato e suonato dagli U BIT, prodotto e registrato da David Campanini.
“Tales for digital bodies”. Qual è il comun denominatore di questi racconti?
Sono i soggetti stessi ai quali sono dedicati, sono scritti per i nostri corpi e di riflesso per le nostre menti. Si canta delle reazioni che abbiamo davanti alle emozioni, agli specchi nei quali ci si riflette, agli avvenimenti sconvolgenti, una voce per alcune delle cose che mettono in pericolo la nostra natura.
Nei nuovi brani affrontate diverse tematiche di rilevanza sociale. Come sono stati concepiti?
Sono venuti di getto, sia per interesse personale nell’indagare la mente sia per la comune necessità di comunicare attraverso la musica cose difficili da dire con le sole parole, perciò testo e melodie sono molto legati anche quando scritti a più mani. La musica va saputa sfruttare come fonte di comunicazione anche per contenuti importanti, di carne e a volte va ascoltata con la pancia.
Primo album in studio, dopo l’Ep “Humans outer space”. Siete passati da atmosfere rock a sonorità più elettroniche. Quanto influisce sul vostro lavoro il fatto che proveniate tutti da esperienze musicali diverse tra loro?
C’è una sorta di scontro creativo, un caos controllato che ci porta a mettere in campo le nostre sonorità preferite con quelle degli altri membri del gruppo. Si ragiona come un corpo, ci si coordina e si suona sia in armonia superando le fasi di disaccordo, cercando di fare tesoro delle differenze.
In questo disco ritroviamo in parte sonorità anni ‘80/90, come i Tears for Fears o i Portishead… complice un certo background musicale?
Decisamente sì, siamo musicalmente figli degli ottanta/novanta che senza troppa nostalgia né pretese reinterpretano sonorità familiari ai primi anni in cui la musica entrava nelle nostre orecchie. Forse anche questa scelta è stata più o meno conscia tanto da trovarsi con naturalezza in tema con i contenuti dei testi e accompagnarli nell’atmosfera generale del disco.
Da chi è nata l’idea dell’artwork di copertina? Cosa rappresenta?
La fotografia di copertina è di Alessandro Messina (chitarra/basso) e quando ce l’ha proposta (dopo vari e tanti tentativi) ci ha subito attirato in maniera ossessiva. Cercavamo infatti un’icona più che un’immagine e la testa della bambola era davvero forte, ci colpiva. In più si parla di corpi e la bambola non ne ha uno proprio, è, come ho detto ad Alessandro, cercare di esprimere “il culto dell’assenza”, celebrare la mancanza. Ci manca il rapporto con il nostro corpo, siamo sempre più solo teste, alcune per giunta vuote. Esattamente come il feticcio in copertina. In più questo è un disco ancora più cupo del precedente, meno scanzonato… più crudo, e questa immagine pensiamo ci aiuterà a trasmettere questo messaggio.
Quanto conta l’empatia in un gruppo?
Direi senza romanticismi che è fondamentale ma non scontata. Va saputa costruire negli anni, anche al di fuori della musica, ma come la musica va coltivata nell’ascolto e fortunatamente abbiamo le orecchie pronte. Questo non significa che siamo sempre d’accordo, anzi le difficoltà tra noi ci hanno aiutato a conoscerci e a crescere musicalmente e a dare un valore a quello che facciamo, che spesso è molto di più che qualcosa di collaterale.

Intervista di Cinzia Canali