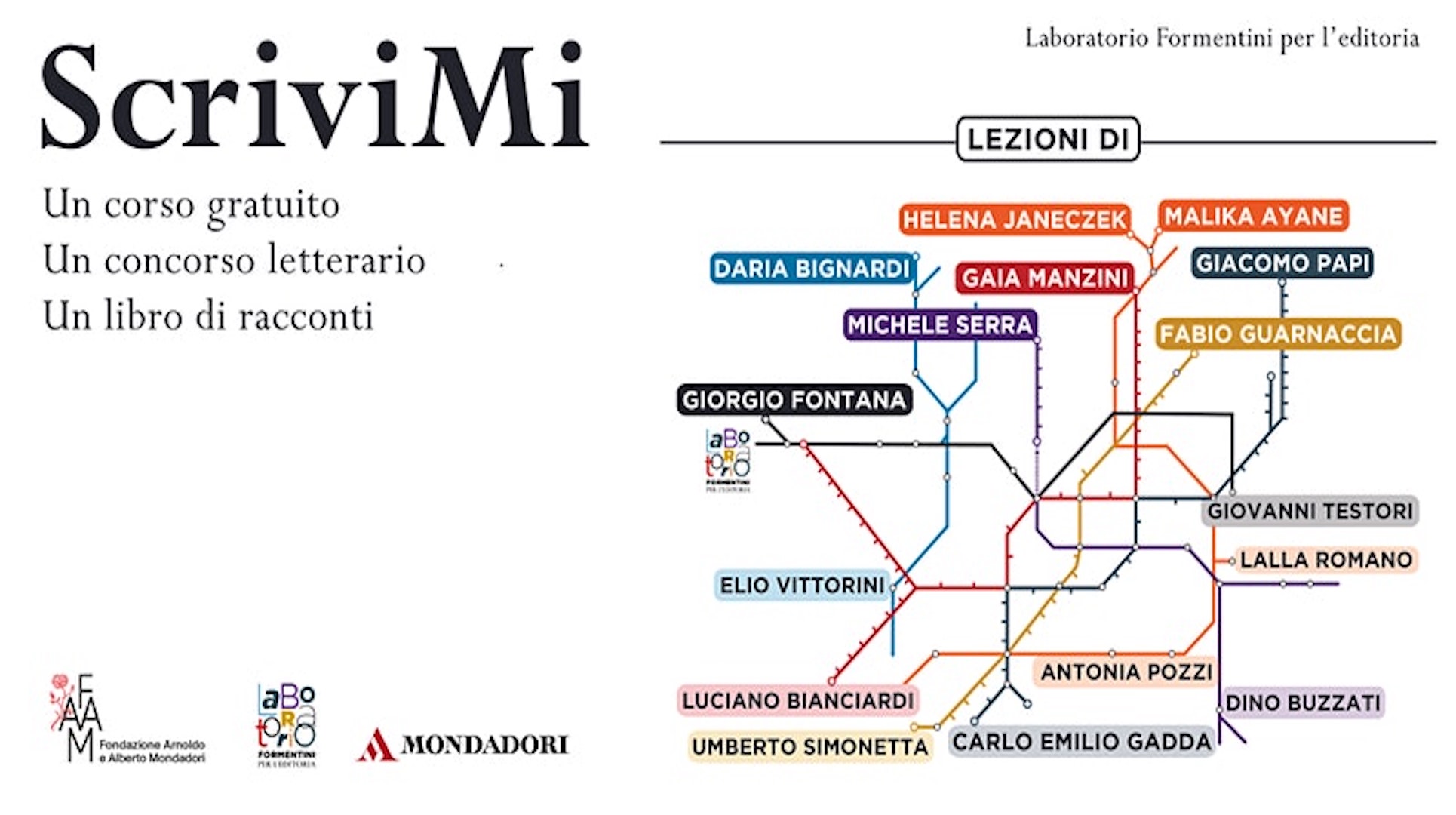Quando Rick Rubin decide di mettersi dietro al banco di missaggio di un nuovo prodotto discografico, nasce sempre un retro pensiero: “quanto gli avranno dato?”.
Al netto del fatto, quindi, che egli sia – di certo – il produttore che più di ogni altro ha influenzato, tracciato inventato e reinventato, la gran parte della musica contemporanea e la carriera di tantissimi artisti, anche nel caso di William Patrick Corgan (nella memoria collettiva, il Billy Corgan deus ex machina degli Smashing Pumpkins), sapere che Rubin abbia deciso di associare il proprio mestiere all’opera di Corgan, ha fatto nascere questa domanda.
La cui risposta risiede in un adagio antico, quanto efficace: cui prodest?

Ogilala (2017 Martha’s Music, Reprise, BMG), la seconda opera solista di Billy Corgan, è talmente distante tanto dai Pumpkins, quanto dalla precedente opera solista di più di dodici anni orsono (The Future Embrace), che – il parere di chi scrive è tutto tranne che obiettivo – l’impronta del produttore è più che percepibile. Un vero e proprio marchio.
La maturità avrà di certo rasserenato gli animi più inquieti del Nostro, ma è impossibile evitare di pensare che l’impronta così a stelle e strisce non sia figlia anche della sapienza del guru del music business per eccellenza.
Ogilala è un disco squisitamente acustico, praticamente senza basso e batteria, dove Corgan si alterna ora al piano, ora alla chitarra mentre splendidi arrangiamenti di archi o di Rhodes Mark II sopiscono ogni ipotesi di rabbia.
E’ il disco della serenità ritrovata, esibita e condivisa: anche il timbro della voce di Billy Corgan sembra meno irato e molto più disponibile al sorriso, ricordando ora la modulazione vocale di Robert Plant, ora quella di Richard Ashcroft. Ed è un piacere per chi ha sempre rispettato, ma mai amato, l’impeto corrosivo delle linee vocali di “Tonight, tonight”, per esempio.
La produzione e la scrittura, come l’uso della voce, rimandano ad ambienti assolutamente quieti: Corgan con il pentagramma sembra disegnare la campagna, ora quella americana quando echi di Plant, Zep e John Frusciante sembrano propagarsi dalle casse (The processional, Aeronaut, Halflife of an autodidact, Amarinthe, Schiloh), ora quella inglese (Archer, The Long Good Bye, Zowie, The Spaniards), in cui è impossibile non rintracciare un modo compositivo, un’inflessione o una semplice ispirazione che ricordano senza invasione Coldplay, Noel Gallagher e Adele (Zowie).
Ogilala è un prodotto assolutamente godibile (escludendo la copertina decisamente inspiegabile per sciatteria e bruttezza rispetto ad un lavoro così elegante a meno di non volerlo così contrappuntare) che ci restituisce un autore affatto piacevole nella maturazione compiuta: che sia figlia di una ritrovata e definitiva serenità ovvero dell’esigenza di riproporsi ad un pubblico che l’ha comprensibilmente messo da parte appare operazione trascurabile, soprattutto se dalla risposta dipenda il giudizio su di un album che, si ripete, risulta pienamente legittimo.
Mellon Collie sta meglio.
Filippo Basile