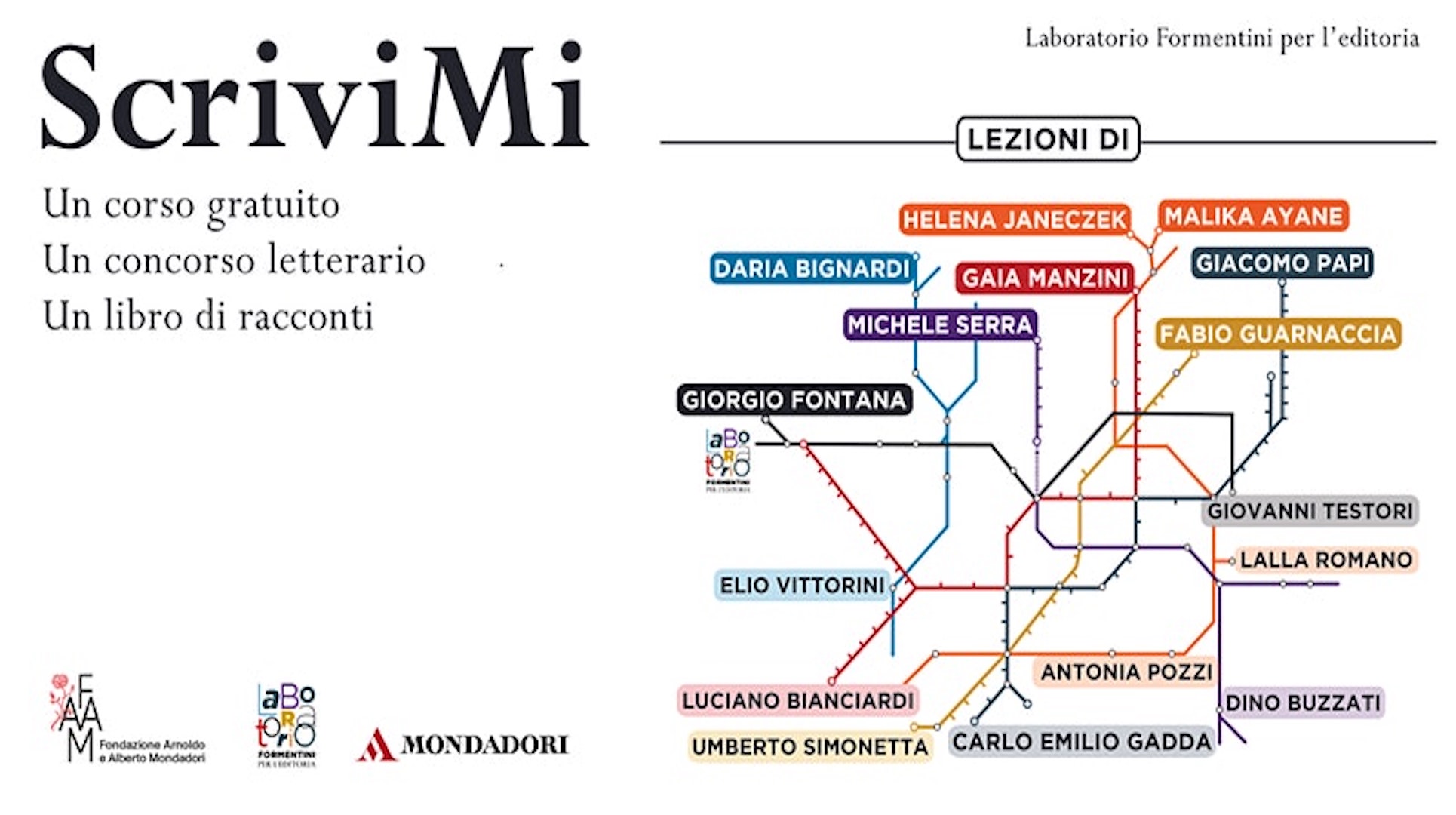Il Sud del mondo ha sempre avuto un cuore nero, nascosto tra le increspature di una inquietudine che scandisce i tempi dell’esistenza. C’è uno stato dell’anima sospeso tra echi di un passato pieno di dolore atavico e la necessità di sopravvivere al presente facendosi carico del peso invisibile di tutti gli errori commessi. Il blues è il linguaggio secolare di un silenzio interiorizzato che diventa un riparo di fortuna dalla tempesta degli eventi e allo stesso tempo mezzo di riscatto. Perché il blues è l’immagine impressa su un dagherrotipo che restituisce volti scavati, occhi spenti e figure umane di un dramma che si consuma nella solitudine di anime alla deriva, comprese quelle che si sono vendute al diavolo.
“Stray Dogs” di Stefano Meli è album di blues antico per l’autenticità con cui è stato concepito, fatto di vibrazioni e silenzi in cui viene catturato il pulviscolo di un mondo perduto fatto di storie di fatica e dignità, così come dei racconti di coloro che continuano a vivere solo nei cuori spezzati. Il paesaggio sonoro di Meli è il perfetto soundscapes per terre di frontiera nei cui spazi prende voce un folk di impronta southern vicino alla sensibilità di David Eugene Edwards in “Secret South” dei 16 Horsepower, così come alla ieraticità dei Wovenhand o al respiro della slide di Ry Cooder. L’album è stato registrato nel Little Lost Cat Studio Recording, un piccolo studio nell’entroterra siciliano, praticamente in solitudine, quasi solo con chitarre ed una scarna strumentazione vintage come un vecchio amplificatore Fender. Il risultato è una musica come poetica per vite in frantumi e per cieli notturni che all’improvviso si rischiarano alla luce di incendi lontani. L’ascolto di “Stray Dogs” riporta alla mente nenie ipnotiche attraverso cui si esorcizzano i propri demoni, facendoli uscire per danzare insieme ed imparare a non averne paura.
L’opener The Stranger è come un rito propiziatorio in cui si invocano le divinità ctonie che regnano nel nostro inconscio, il tremolo della successiva Absence unita al violino di Anna Garcia Galba fa venire in mente le decadenze western della colonna sonora di “The Proposition” di Nick Cave e Warren Ellis, così come i magnifici intarsi riverberati dell’accordatura aperta di Song of Indifference. Ghost Ship è un canto disperato giocato tutto sulla dinamica dello sfrigolio metallico dello slide e del violino come controvoce; in Down there at the Bottom troviamo i Tinariwen che ci bagnano le labbra con acqua fresca un attimo prima di svenire sotto la morsa di un sole cocente. La title track è come uno scrigno che racchiude la sintesi di un viaggio faticoso in cui la chitarra raggiunge livelli di fascinazione assoluti con il suo tremolo ed i riverberi analogici applicati a suoni scarni ma ricchissimi di sfumature e profondità. Si segnala la quiete rassicurante di Far, prossima all’Americana di “Good Dog, Happy Man” di Bill Frisell a cui fa seguito l’epilogo di At the End.
Quando Stefano Meli ha registrato “Stray Dogs” non avrebbe immaginato che quelle musiche sarebbero state la perfetta sonorizzazione dei giorni nostri, delle immagini di strade vuote, città abbandonate e di apocalissi che si consumano da sempre in microcosmi domestici. Disco da ascoltare assolutamente ad occhi chiusi.
Giuseppe Rapisarda