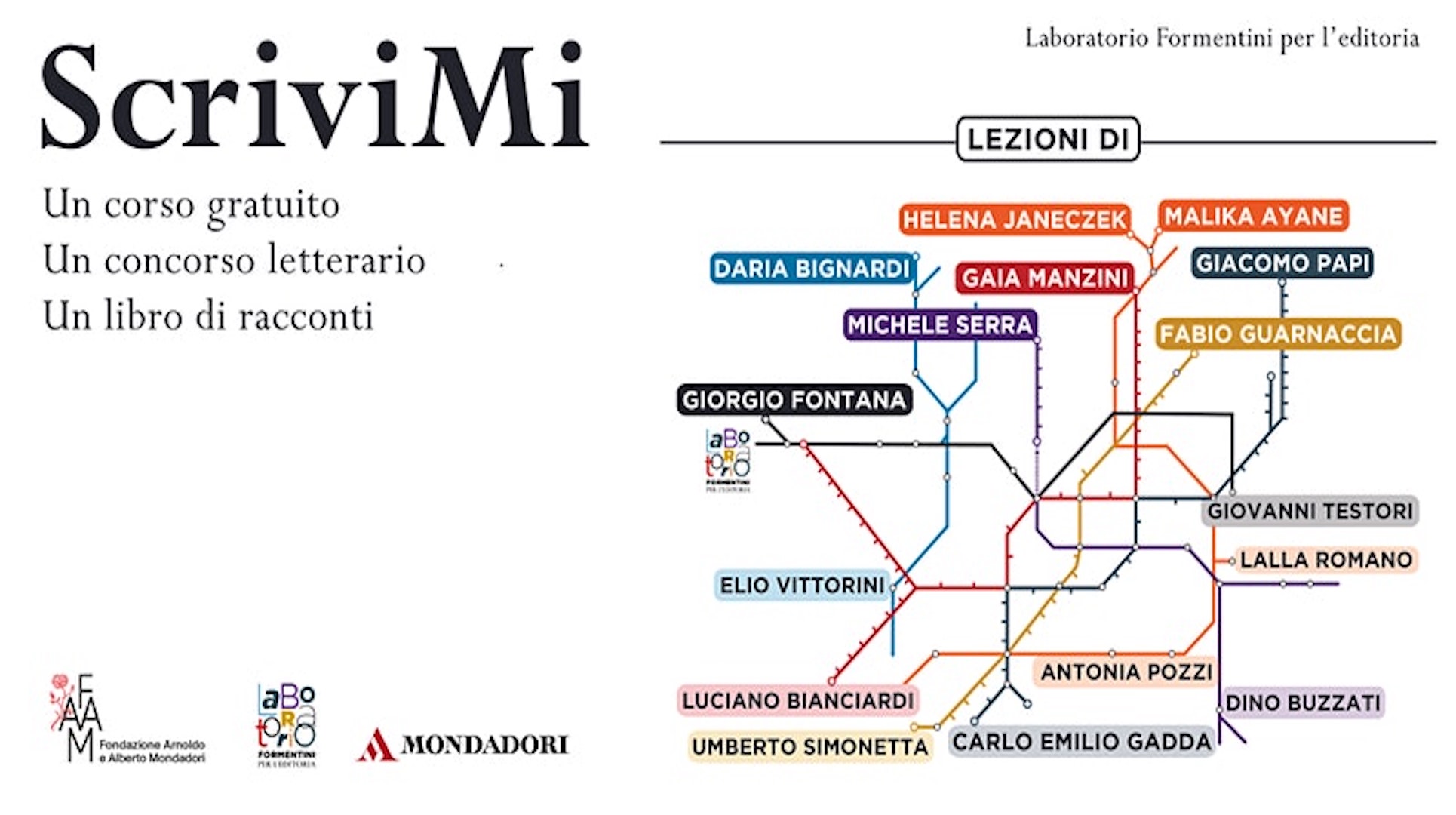Jen Gloeckner è in giro da almeno quattordici anni, considerato che il debutto della cantante del Wisconsin, intitolato “Miles Away”, risale al 2003 a cui ha fatto seguito sei anni anni più tardi “Mouth Of Mars”. Otto anni dopo la Gloeckner dà alle stampe undici nuove canzoni che, rispetto ai lavori precedenti, sono il risultato di un maggiore livello di ricercatezza nel suono e nella produzione. Ne viene fuori un cantautorato dalle tinte scure e fondamentalmente introspettivo che attinge ai languori di Mazzy Star e Cowboy Junkies ed a cui si unisce l’utilizzo di un’elettronica funzionale a creare un legame con un’idea di pop più evoluto. Per imprimere un’atmosfera di intimità ai brani, le registrazioni sono state eseguite all’interno della camera da letto della Gloeckner a Dubuque in Iowa, ed il missaggio è stato realizzato presso lo studio Miner Street Recordings di Philadelphia da Brian McTear (Marissa Nadler, Midlake, The War on Drugs) e Matt Poirer.

“Vine”, tra i cui i credits compaiono i nomi di John Ashton dei Psychedelic Furs, Angela Mattson dei californiani In The Valley Below, ed Henry Padovani, chitarrista nei Police prima dell’avvento di Andy Summers, è un album non privo di una complessiva buona scrittura ma che a tratti suona discontinuo. L’anima della Gloeckner sembra divisa tra elementi apparentemente inconciliabili tra loro: passato e presente, metropoli e città di provincia, buio e liberazione, in un condensato dove alla base vi è il linguaggio del folk e delle esperienze di una canzone declinata al femminile. Però non tutto sempre funziona come dovrebbe.
Se l’opener Vine è un pezzo dalle venature etniche, del tutto trascurabile è lo strumentale Firefly (War Dance). Breathe è attraversata da un brivido di elettronica minimale che però non ferisce abbastanza, al contrario di Ginger Ale il cui incedere marziale si concede ad un’apertura ariosa. Blowing Throught è in stile Chris Isaak sull’onda di un noir romantico, allo stesso modo degli sdilinquimenti di Counting Sheep sottolineati dal reverbero applicato alla voce. La parte finale dell’album è quella meglio riuscita con Prayer, forse in assoluto il momento più significativo, dotata di un sincero decadentismo eighties, Colors la cui austerità sottolinea la ricchezza di pathos e Row With The Flow, ballata agrodolce dal retrogusto vintage. Toccante è la conclusiva Sold in cui Jen canta con disillusione che le stelle stanno candendo alla velocità della luce.
“Vine” è un album senza dubbio con buone intuizioni ed altrettante ottime intenzioni ma che manca di uno spessore aggiuntivo nei brani, di una volontà di osare di più orientandosi verso soluzioni meno allineate ed innocue. Perché la musica deve saper far male, altrimenti diventa mero intrattenimento, anche se di classe.
Giuseppe Rapisarda